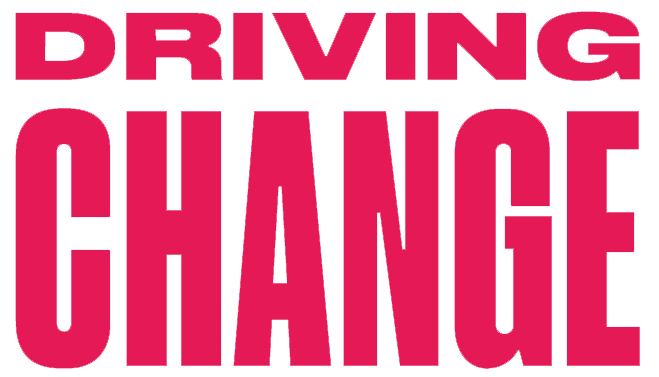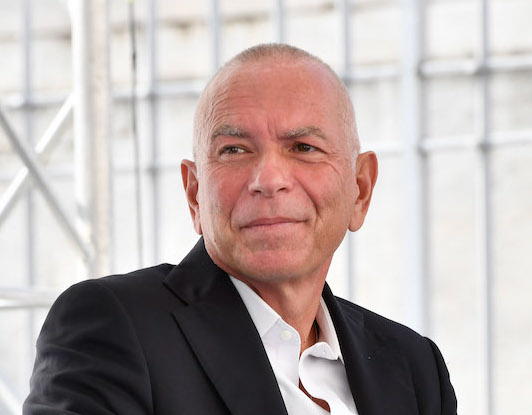Stazioni ferroviarie italiane: centri di scambio modale, dove poter parcheggiare la bicicletta prima di prendere il treno, e all’arrivo raggiungere la fermata dell’autobus attraverso percorsi pedonali protetti. Poli di servizi, non soltanto hub commerciali, utili nelle grandi città per chi non ha altrimenti il tempo di fare la spesa, ma anche centri di assistenza medica, centri vaccinali, sedi della protezione civile. Il ruolo delle stazioni ferroviarie è in continua evoluzione: il Gruppo FS ha deciso di valorizzare anche quelle dei centri minori, in funzione delle esigenze locali e in collaborazione con i Comuni. Driving Change ne ha parlato con l’architetto Antonello Martino, Responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni, Direzione Stazioni RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).
Qual è la vision di Ferrovie dello Stato in merito all’evoluzione del ruolo delle stazioni ferroviarie e alla loro valorizzazione, anche in chiave di utilità pubblica e sociale?
Partiamo dalla storia: molti anni fa è partito un piano per riqualificare le stazioni che avevano un problema di adeguamento in termini di accessibilità a persone con ridotta mobilità. Il progetto partiva da quelle più affollate, che avevano dei numeri più importanti in termini di traffico passeggeri: sono intorno alle 630-640 sulle 2200 complessive che abbiamo, e captano circa il 90% del traffico passeggeri in Italia. Sono le stazioni da aggredire prima, perché mettendo a posto quelle si copre il grosso della nostra utenza. Poi il processo si allarga anche alle rimanenti stazioni.
Poi che succede?
Negli anni successivi, il Covid e tematiche quali la mobilità sostenibile e lo sharing mobility, che sono diventate centrali nel linguaggio e anche nelle politiche di trasporto, sia nazionali sia locali, delle città e delle Regioni, hanno fatto individuare la stazione come un luogo che era al centro delle città, e che quindi aveva delle grandissime potenzialità come hub trasportistico e come polo funzionale. Come hub trasportistico perché in una stazione, anche la più piccola e meno infrastrutturata, di sicuro il treno ci passa, e anche un autobus, magari non proprio vicino, non proprio collegato bene, ma insomma nelle vicinanze della stazione. Nelle stazioni medie, in quelle grandi e ancora di più in quelle grandissime dove ci sono le metropolitane, c’è la sharing mobility, gli autobus, i pullman, i BRT (bus rapid transit o trasporto rapido tramite autobus, ndr), quindi ci sono tutta una serie di collegamenti. È diventato prioritario potenziare al massimo questo ruolo di hub intermodale.
E al di là dei trasporti?
L’altro aspetto è quello del polo dei servizi. Le grandi città hanno appunto il problema di infrastrutturare e adeguare dal punto di vista trasportistico dei centri importanti, ospedali, università, scuole e così via. Ma nel momento in cui c’è già un hub trasportistico, se ci sono degli spazi a disposizione possono essere occupati da una serie di funzioni. Nel corso di questi anni le stazioni spesso sono diventate degli hub commerciali. Roma, Milano, Napoli, Venezia, Mestre… Questo elenco potrebbe allungarsi un po’, non tantissimo, nel senso che per fare diventare la stazione un hub commerciale c’è necessità di un numero di utenti molto alto che passa nella zona della stazione, ma soprattutto c’è bisogno che passi nella stazione nell’arco di tutta la giornata. Spesso invece le stazioni sono super affollate la mattina, a ora di pranzo e la sera, quindi nelle fasce orarie dei pendolari o degli studenti che prendono il treno. In quel caso mettere dei negozi nelle stazioni non funziona, anche perché chi vive in una città media o piccola, se deve acquistare un capo di abbigliamento o un paio di occhiali, probabilmente lo fa nel negozio sotto casa o in quello nel centro della città, o comunque dove è abituato ad andarlo a prendere. È un servizio invece che è utile per chi vive nelle grandi città, che esce di casa la mattina dal proprio quartiere quando i negozi sono chiusi e torna la sera quando i negozi sono sempre chiusi, quindi passando in stazione può fare quegli acquisti durante la settimana che sotto casa non potrebbe fare. Quindi tutti i progetti che abbiamo sviluppato in questi anni sono tesi non solo ad adeguarci alle norme che garantiscono la piena accessibilità a tutte le stazioni, ma anche al potenziamento delle stazioni come hub trasportistico e come polo di funzioni.
Per le stazioni che non sono adatte ad essere un hub commerciale?
Il numero di stazioni che possono diventare un centro commerciale è abbastanza ridotto, per le altre però stiamo sperimentando delle altre opzioni: laddove non funziona il negozio, potrebbe funzionare lo studentato per gli studenti universitari, oppure un centro di assistenza medico, o ancora un centro vaccinale o altre funzioni che non sono commerciali. Non danno un reddito di sviluppo commerciale importante, ma sono delle funzioni che messe al centro delle città sono utili per chi passa in stazione la mattina, la sera, il pomeriggio, e trova comodo trovare delle funzioni all’interno delle stazioni. Quindi tutti i progetti di potenziamento che noi stiamo facendo sulle stazioni sono fatti con questo indirizzo. Per farlo è fondamentale che nella definizione dei progetti noi apriamo dei tavoli di condivisione con gli enti e gli stakeholder locali, perché la politica urbanistica, la politica trasportistica delle città non le decidiamo noi ma le decidono i Comuni. Quindi con i Comuni e anche con le Regioni definiamo come collegare al meglio, sia dal punto di vista trasportistico ma anche dal punto di vista urbanistico, la stazione alla città, in maniera tale che ci sia una maggiore compenetrazione, che la stazione sia sempre più vista come una parte centrale della città.
A proposito delle stazioni dei centri minori, quelli sotto i 15mila abitanti, come vi muovete?
Nelle città piccole pensare di mettere dei negozi nelle stazioni non funziona. Può funzionare un bar, e a tal fine noi facciamo degli interventi anche sulla piazza, spesso rendendola totalmente o parzialmente pedonale. Quindi il bar della stazione non diventa un bar utilizzato da chi deve prendere il treno che correndo si prende un caffè e poi sale sul treno, ma può essere un luogo, una piazza dove le persone che abitano nell’area circostante alla stazione vanno in stazione non per prendere il treno ma per prendere un caffè. Ma ci sono anche altre funzioni importanti, dalla protezione civile alle strutture sanitarie, fino ad altre attività che hanno finalità sociali più che commerciali. Per noi va sempre bene, perché la sicurezza nelle stazioni si garantisce attraverso la tecnologia, con le telecamere di controllo; e attraverso le forze dell’ordine, sia statali sia nostre – è stata creata una società che si chiama FS Security, proprio per potenziare la sicurezza all’interno delle stazioni. Ma si garantisce anche attraverso una presenza costante di utenti e delle funzioni che durano tutto l’arco della giornata, per cui la stazione diventa luogo vissuto e non luogo abbandonato in varie sue parti. Poi la conformazione architettonica della stazione fa anche tanto, perché la qualità architettonica degli spazi, il design e l’illuminazione possono essere analizzati proprio per evitare delle zone d’ombra o scarsamente visibili, per evitare che ci siano dei luoghi che abbiano poco sicurezza reale o percepita.

Quale lo stato dell’arte del progetto Stazioni del Territorio, promosso dalle società del Gruppo FS e rivolto proprio agli scali ferroviari dei comuni con meno di 15 mila abitanti per trasformare le stazioni in centri polifunzionali?
Abbiamo rilasciato l’anno scorso le prime tre stazioni del territorio, che sono Popoli-Vittorito in provincia di Pescara, Urbisaglia e Matelica in quella di Macerata. Attualmente sono in corso i lavori alla stazione Loreto ancora nelle Marche, Antrodoco nel Lazio e Baiano di Spoleto in Umbria. Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo inizieremo i lavori alle stazioni di Arona, nel novarese sul lago Maggiore, Passignano sul Trasimeno sull’omonimo lago in Umbria e Albizzate, in provincia di Varese. Sono dei progetti che facciamo a quattro mani con i Comuni che ci accompagnano nel decidere le funzioni da mettere all’interno delle stazioni.
 E le stazioni del cosiddetto cratere cioè nell’area del cratere sismico, sorta di sviluppo di questo progetto?
E le stazioni del cosiddetto cratere cioè nell’area del cratere sismico, sorta di sviluppo di questo progetto?
Quello del cosiddetto cratere è un sottoinsieme di finanziamento, cui lavoriamo soprattutto con il contratto di programma del MIT per il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, che ha dei capitoli di spesa specifici per le stazioni ferroviarie. Poi ci sono altre fonti di finanziamento, per esempio i fondi stanziati per il Giubileo a Roma, e ci sono stati dei fondi stanziati dal governo per le zone che avevano avuto il sisma nel 2009 e nel 2016. In questo caso noi abbiamo candidato le stazioni di Fabriano, di Tolentino, di Macerata, di Ascoli Piceno nelle Marche, quelle di Baiano di Spoleto e di Spoleto in Umbria, di Rieti e di Antrodoco nel Lazio e dell’Aquila in Abruzzo. Essendo in aree potenzialmente critiche dal punto di vista del sisma, stiamo facendo degli interventi di consolidamento nei fabbricati. In tutte le stazioni poi, indipendentemente dal cratere, laddove c’è necessità facciamo un’analisi di vulnerabilità e degli interventi di consolidamento strutturale finalizzati proprio alla protezione sismica, per adeguarle all’evoluzione della normativa.
Ci fa un esempio della situazione di queste stazioni rigenerate?
Nella stazione di Popoli-Vittorito, con la collaborazione del Comune, sono state attivate una serie di funzioni più prettamente mediche. Il Comune ci ha espresso, sin dall’inizio della collaborazione per la definizione del progetto, l’esigenza di avere degli spazi per esempio per le vaccinazioni stagionali, per delle visite specialistiche, perché avevano difficoltà a trovarli all’interno del paese. Quindi abbiamo ristrutturato i fabbricati dei viaggiatori in funzione di queste esigenze, attrezzandoli anche a tal fine.
Ci fa un esempio dell’evoluzione delle stazioni oggi in Italia?
Le stazioni sono al centro delle città: c’è sempre maggiore esigenza di mobilità, ma rispetto a prima c’è bisogno di una mobilità integrata, quindi c’è grande spazio per la sharing mobility, per la mobilità sostenibile, la mobilità pedonale, la mobilità ciclabile. Sempre più spesso all’interno delle stazioni mettiamo delle velostazioni e i collegamenti di ultimo miglio con le piste ciclabili. Spesso infatti succede che vengano realizzate dalle città piste ciclabili che arrivano nei pressi della stazione, ma che manchi il collegamento finale. Per esempio stiamo facendo degli interventi sulle aree esterne della stazione di Pesaro, che è una delle città con la maggior presenza di piste ciclabili. Eppure se lei andava nel corso degli anni passati davanti a quella stazione vedeva una specie di cimitero di biciclette, perché non c’era un posto dove sistemarle, quindi venivano lasciate un po’ alla fortuna davanti alla stazione, un po’ abbandonate, attaccate ai pali in maniera disordinata. Stiamo cercando di razionalizzare gli spazi esterni creando delle strutture dedicate alle biciclette, perché bisogna stimolare questa intermodalità ma anche farlo in maniera ordinata.
Ce ne fa anche un altro?
L’attenzione allo scambio modale tra le diverse modalità di trasporto: quasi sempre c’è una fermata degli autobus davanti alla stazione, ma magari il collegamento pedonale dall’uscita della stazione alla fermata dell’autobus non è un collegamento pedonale protetto. Dobbiamo sempre pensare alle mamme con le carrozzine e coi bambini, alle persone anziane, a quelle che hanno problemi di deambulazione, il fatto di garantire un percorso pedonale chiaro e protetto è un elemento pregnante. Per questo nella definizione dei progetti ci colleghiamo con i Comuni in maniera tale da razionalizzare questo scambio modale, perché sempre di più l’utente qualifica la qualità del suo spostamento non in funzione del singolo pezzo di trasporto, bensì di quello che deve attraversare dal momento in cui esce di casa al momento in cui arriva al luogo cui è diretto. Quindi si può anche fare un percorso in treno perfetto, in orario, veloce, in piena agiatezza, ma se poi per andare alla stazione e per andare al luogo dove devo arrivare ho difficoltà a prendere l’autobus, non ho un collegamento pedonale protetto, allora la qualità del mio viaggio ne risente: per questo è importante intervenire, a volte anche al di fuori del perimetro delle stazioni, in collaborazione con gli enti locali.