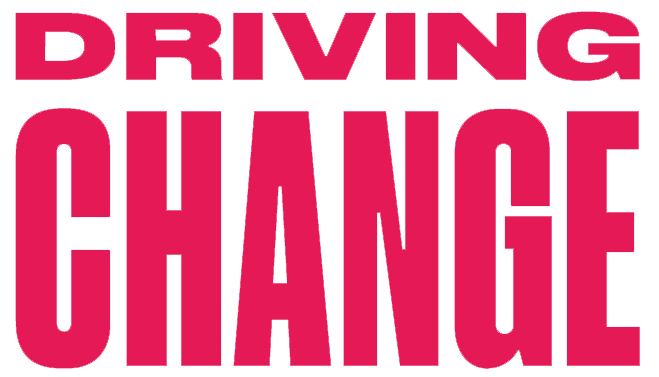Posidonia spiaggiata: il primo impianto italiano che la utilizzerà per generare biogas e quindi energia si realizzerà a Pollica, nel Cilento, in provincia di Salerno. Ne abbiamo parlato con Stefano Pisani, sindaco di Pollica, che da anni si batte per realizzare il progetto, e sta vedendo il traguardo.
Posidonia spiaggiata per produrre energia: com’è nata questa idea così innovativa?
Da una circostanza abbastanza banale. Quando ti trovi a fare il sindaco di una località turistica balneare, spesso i turisti ti segnalano la spiaggia sporca. Per molti frequentatori dei litorali si commette un errore di fondo: si considera la Posidonia spiaggiata, fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema marino, compresa la produzione di energia e la salvaguardia della biodiversità in mare, alla stregua di un rifiuto, perché magari dà fastidio alla nostra passeggiata in riva al mare. O magari perché la normale evoluzione della banchetta di Posidonia produce dei piccoli insetti che invece sono fondamentali per l’equilibrio del nostro ecosistema costiero. Come sindaco devo trovare soluzioni che non devono essere neanche eccessivamente impattanti.
E quindi come si è mosso?
Abbiamo cominciato a immaginare una gestione corretta della Posidonia che riuscisse a garantire una adeguata sopravvivenza dell’ecosistema della banchetta di Posidonia, e allo stesso tempo ci consentisse di accogliere anche coloro che avevano una minore sensibilità dal punto di vista della comprensione del ruolo della Posidonia. Ricordiamoci che la Posidonia spiaggiata non è altro che Posidonia secca che esaurisce il suo ciclo di vita: la corrente la deposita in mare, ma ha più funzioni fondamentali, la prima delle quali è quella di proteggere le nostre coste dall’erosione costiera. Quindi noi consentiamo innanzitutto alla Posidonia durante la stagione invernale di rimanere sulle nostre coste per esaurire la sua prima funzione. Dopodiché, per continuare a garantire la funzione di protezione dall’erosione costiera, una quantità non elevatissima di questa Posidonia la interriamo sotto la spiaggia in modo da compattare le dune e garantire una maggiore difesa della costa. Fino a quando è possibile lasciamo alla Posidonia la possibilità di gestire il ciclo di vita dei microrganismi che si generano nella banchetta. Esaurita questa funzione è necessario gestirla.
Si innesta qui l’idea dell’impianto?
Proprio così. Abbiamo immaginato un ciclo di vita della Posidonia che si esaurisse all’interno di un ciclo di fermentazione, un classico impianto di biogas che ha una caratteristica molto importante. Abbiamo cercato il giusto mix di gestione tra Posidonia spiaggiata e FORSU, rifiuto umido da raccolta differenziata, facendo diverse ricerche affinché si raggiungesse l’ottimo di produzione di biogas attraverso il mix. Normalmente conosciamo tutti l’esistenza di impianti che producono biogas ed energia elettrica dalla fermentazione del rifiuto umido, molto meno dalla Posidonia perché non ha una capacità adeguata di produzione dal punto di vista economico, non si raggiunge facilmente un punto di break even. Ma in questo caso l’innovazione del nostro impianto è proprio data dal mix di input che mettiamo all’interno del nostro impianto.
Vi siete anche ispirati a delle esperienze realizzate all’estero?
Sì, soprattutto a piccoli o grandi impianti che gestivano già la Posidonia in quantità diverse e in modalità diverse. Vista la possibilità di realizzare l’impianto stesso abbiamo cominciato ad analizzare i limiti del contesto. Noi siamo un’area parco nazionale dove realizzare degli impianti di trattamento di “rifiuti” non è semplice, anzi è quasi impossibile. La Regione Campania aveva scelto una taglia medio alta di impianti di compostaggio e di trattamento del rifiuto umido, perché riteneva nel suo piano di gestione di rifiuti che la taglia inferiore, quella che abbiamo scelto per il nostro impianto, fosse troppo piccola, 7mila tonnellate, compresa Posidonia, rifiuto umido, strutturante e quant’altro. Abbiamo innanzitutto dovuto convincere loro per farci avviare al percorso autorizzatorio, perché la Regione riteneva assolutamente non sostenibile quell’impianto.
Come avete convinto la Regione?
In un modo molto banale: l’impianto di Pollica si realizza in project financing, a totale carico del soggetto privato. Anche questa è un’esperienza molto interessante, perché la condivisione dell’impianto ci ha consentito di superare una serie di barriere in termini di percezione del progetto. Non ha funzionato il solito meccanismo not in my backyard, per noi ha funzionato l’esatto contrario. All’interno del parco nazionale è molto complicato realizzare gli impianti, infatti stiamo sfruttando nel percorso autorizzatorio due deroghe, una dal punto di vista ambientale rispetto al piano del parco nazionale attualmente vigente e l’altra rispetto al piano paesaggistico di tutela.
È un rispetto di nome e di fatto?
Certo: l’impianto si inserisce in un’area di grande valore ambientale, dove però abbiamo già realizzato in modo assolutamente ecocompatibile una struttura fondamentale per la gestione dell’interazione uomo-ambiente, che è il centro di raccolta differenziata. Pollica fa l’83% di raccolta differenziata in media tutto l’anno, anche nei mesi di maggiore carico turistico che sono agosto, luglio, giugno e settembre. Anche i fanghi di depurazione confluiranno all’interno dell’impianto di trattamento della Poseidonia spiaggiata. Il potenziale produttivo dell’impianto è pari al fabbisogno di 500 famiglie. Pollica è un piccolo Comune, durante l’inverno siamo circa 2200 abitanti, circa 500 famiglie.
In questo modo siete autosufficienti?
Pollica è una fonte di produzione di energia rinnovabile costante, che non ha nessuna connessione con il ciclo vitale degli elementi, sole, vento, acqua. È invece una fonte stabile che ci consente all’interno del nostro progetto di comunità energetica rinnovabile di stabilizzare il percorso di disconnessione della nostra comunità dalle fonti di produzione di energia non rinnovabile, su cui si approvvigiona la nostra vita elettrica. Normalmente in Italia siamo messi abbastanza male e quindi ci è sembrato particolarmente rilevante insistere in questa direzione. Da quello che a molti appare una grande negatività, ovvero le spiagge “sporche” di Pollica che invece vengono premiate da 30 anni per essere tra le migliori spiagge d’Italia, oggi siamo arrivati a conclusione di un percorso che ci porterà a produrre l’energia per i nostri cittadini da questa pianta straordinaria che è la Posidonia.
Siete riusciti a mettere insieme le esigenze dei turisti che non conoscono l’importanza della Posidonia, con quelle del suo smaltimento e con le esigenze economiche dei cittadini?
È sicuramente un progetto win-win, questo lo dico con orgoglio. Nel bando di project financing attraverso il quale abbiamo affidato la realizzazione e la contestuale gestione per 30 anni dell’impianto stesso, c’è stata offerta la possibilità – non appena completiamo la realizzazione e andiamo a regime con l’impianto – di ridurre la bolletta energetica dei nostri cittadini, con una fee annuale da stabilire successivamente. Ma ci consente addirittura di risparmiare circa 150 mila euro del costo di conferimento del rifiuto umido, che normalmente pagavamo per smaltire il nostro rifiuto umido. Quindi questo è il primo risparmio, riduzione della bolletta energetica e riduzione della tassa sui rifiuti a favore dei nostri cittadini.
Spiegato questo ai suoi concittadini, sono diventati sostenitori del progetto?
Straordinari sostenitori, soprattutto perché da tempo a Pollica abbiamo un’ottima relazione con i nostri rifiuti, i cittadini, ma anche i nostri cittadini temporanei, i nostri turisti, che anche quando in Campania c’era l’emergenza rifiuti erano quelli che facevano la raccolta differenziata. A Napoli, dove hanno l’abitazione principale, c’erano i rifiuti per strada, a Pollica loro facevano la raccolta differenziata. Quindi la cultura di gestione della nostra corretta correlazione con l’ambiente è fondamentale, e ne abbiamo fatto una delle nostre cavi di sviluppo. C’è anche da dire che non ci accontentiamo di mettere in campo delle buone iniziative sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, ma tendiamo a formare quelle che sono le future generazioni.
In che modo?
L’impianto di biogas sarà realizzato nei pressi del centro di raccolta e del nostro depuratore, che si trovano nel percorso di escursionistico naturalistico, dove è possibile incontrare una straordinaria biodiversità. Il Parco Nazionale del Cilento raccoglie più o meno il 33 per cento della biodiversità nazionale vegetale e animale, e lì le persone potranno conoscere due pezzi: il valore del nostro ambiente, e anche come l’essere umano può avere una relazione assolutamente proattiva e positiva nei confronti dell’ambiente, mantenere un equilibrio che spesso manca. Per il mancato raggiungimento dell’equilibrio ogni tanto ci giustifichiamo, però dobbiamo fare qualcosa, trovare delle soluzioni che ci consentano non impattare negativamente sul contesto nel quale viviamo, anzi tendere a rigenerare le risorse che normalmente traiamo dal nostro pianeta.
In estrema sintesi, da un punto di vista tecnico, come funzionerà l’impianto?
È abbastanza semplice: recuperiamo la posidonia dall’arenile, la portiamo all’interno dell’impianto, dove viene lavata con l’acqua di depurazione filtrata a raggi ultravioletti, quindi il primo pezzo di economia circolare lo generiamo nella prima fase. Normalmente dovrebbe essere lavata con acqua dolce e quindi generare un utilizzo di risorsa idrica non potabile, ma comunque dell’acqua che può essere utilizzata per irrigazione. Vicino al depuratore abbiamo applicato un trattamento a raggi ultravioletti che ci consente di utilizzare l’acqua di depurazione per un uso non potabile, duale. Quindi l’impianto sarà connesso al depuratore per il lavaggio della posidonia, con la raccolta di tutte quelle che sono le risultanze del lavaggio. Molto spesso troviamo tanta sabbia quando asportiamo la posidonia, che va ricondotta sull’arenile per un ripascimento corretto. Viene quindi eliminata la parte dei rifiuti, anche se le nostre spiagge non presentano una quantità di rifiuti rilevante: ci sono sicuramente un minimo di microplastiche, ma è veramente una quantità ridotta. Poi viene conferito all’interno dell’impianto per la fermentazione mista il rifiuto umido che viene recuperato dal centro di raccolta che è aderente all’impianto stesso, e viene lasciato a fermentare per un numero di giorni necessario. Questo ci consente di produrre il biogas che attraverso un bruciatore genera corrente elettrica. Si tratta di un impianto anaerobico, quindi non c’è la produzione nemmeno di cattivi odori. È abbastanza semplice, il tecnicismo sta nel giusto mix, nel corretto bilanciamento degli elementi di input, se manca quello non si produce energia o se ne produce troppo poca, quindi la chiave del successo dell’impianto è in quello. La tecnologia è abbastanza matura, la noi conosciamo tutti, ma il giusto mix mancava.
Che tipo di difficoltà avete incontrato nel portare avanti il progetto?
Mi sarebbe piaciuto rispondere: è stato semplice, invece è molto molto complicato, soprattutto quando immaginiamo di creare innovazioni. Le innovazioni sotto il profilo privatistico sono un po’ più agevoli da realizzare, è molto più complicato per una pubblica amministrazione avere uno slancio di creatività, soprattutto quando poi è la governance politica ad avercelo e non una struttura tecnica che indirizza in quella direzione. L’handicap più grosso che abbiamo in Italia è rappresentato sicuramente dalla burocrazia. Non avere procedure semplificate per mettere in campo delle azioni innovative in settori critici come la gestione dei rifiuti, con la necessità di dover ogni volta immaginare prima di subire il processo dell’intenzione e poi poter dimostrare il valore della progettualità, ci ha obbligato a lavorare senza sosta per quattro anni, e stiamo ancora cercando di smarcare gli ultimi pezzi che mancano. Però la perseveranza è sicuramente l’elemento determinante per realizzare grandi innovazioni di processo, lo sappiamo benissimo, non c’è altra soluzione. Raccontare le esperienze va bene, molto spesso però è necessario che quelle esperienze si traducano in indicazioni normative, regolamentari, di contesto necessarie per gli altri. Quando questo impianto lo raccontiamo ai giapponesi, come è successo di recente, poi ci chiamano e ci dicono: perché non venite a realizzare in pochissimo tempo questo impianto da noi, così ci date una mano a gestire la nostra posidonia? Il mio timore è che il mio impianto di Pollica arriverà dopo di quello di Tokyo, e questo mi dispiace molto.
A questo punto realisticamente quali potrebbero essere i tempi per la realizzazione?
Speriamo la prossima primavera di essere operativi, con l’impianto completato. Dopo quattro anni è un grande risultato, tenuto conto che molto spesso la competenza dei decisori amministrativi e della pubblica amministrazione non è così spiccata come vorremmo.