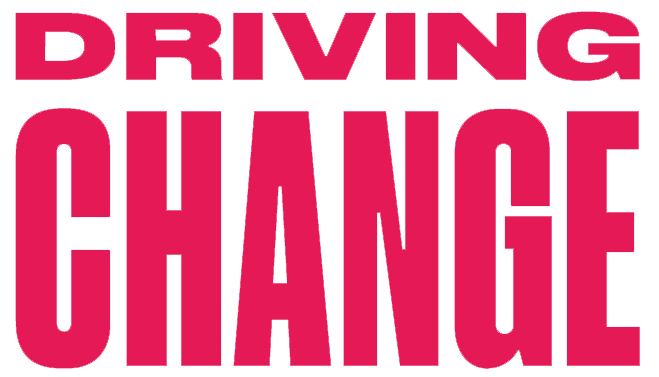Sharath Jeevan è autore di Intrinsic: Un manifesto per riaccendere la nostra spinta interiore. Sharath è un imprenditore sociale proveniente dal mondo degli affari e della consulenza, che ha contribuito al lancio di STIR Education — un’organizzazione che aiuta gli insegnanti a migliorare le proprie prestazioni grazie a una maggiore motivazione e alla condivisione di esperienze — in molti paesi, tra cui India, Indonesia e alcune parti dell’Africa. Ora dirige Intrinsic Labs.
Matthew Bishop (MB): Il pubblico di questo programma, Sharath, è costituito da persone consapevoli dell’esigenza di un servizio pubblico più efficace, che riconnetta le persone con talento, intuizione e capacità di leadership nel dominio del servizio pubblico. Mi chiedevo se potessi dire in una frase — perché dovrebbero leggere il tuo libro?
Sharath Jeevan (SJ): Grazie, Matthew, è un vero piacere essere qui. Penso sia estremamente importante per chi di noi guida il cambiamento nel servizio pubblico sapere cosa ci motiva profondamente come individui e come leader. L’idea è cercare di trovare una motivazione duratura dentro di noi, con l’intento che questo possa aiutarci a motivare le persone intorno a noi — i nostri team, se ne abbiamo, ma anche, naturalmente, come cittadini. In fin dei conti il nostro lavoro è mirato proprio a questo, e vale tanto se siamo funzionari pubblici, quanto se siamo leader politici o cerchiamo di produrre cambiamento nel settore sociale o no-profit, ecc. Questi sono temi universali di cui parla il libro.
MB: Nel libro descrivi in modo molto efficace diverse tendenze che hanno portato molte persone a perdere il contatto con ciò che le motiva dall’interno, spingendole a essere guidate da fattori esterni — quelli che tu chiami “estrinseci”. Senti davvero che c’è una crisi enorme nel mondo dovuta a questa perdita di connessione con noi stessi, che è alla base di molti problemi che si manifestano in vari ambiti della vita, e che sta diventando disfunzionale in molte parti del mondo. Ma potresti spiegarci: qual è il problema chiave che pensi dobbiamo risolvere in questo momento, e che Intrinsic si propone di affrontare?
SJ: Sì, penso che si tratti di spostare il nostro indicatore motivazionale, quel “quadrante” motivazionale, lontano dai fattori estrinseci o esterni. Per esempio, nel mondo del lavoro pensiamo molto allo stipendio, allo status, a quanto sia altisonante il nostro titolo di lavoro, a quanto sia lussuoso il nostro ufficio. Sono tutte cose importanti — non stiamo dicendo che non lo siano — ci sono molte persone nel mondo che non le hanno, e dobbiamo assicurarci che le abbiano. Ma per noi che già le abbiamo, il loro effetto nel tempo tende a diminuire. C’è un effetto di saturazione.
Stavo parlando con un trader alla City di Londra che ha ricevuto un bonus di 21,5 milioni di sterline per l’anno. E la sua prima reazione, quando il suo capo gliel’ha annunciato, è stata: “Devo lavorare di più, perché so che qualcuno nell’ufficio accanto ha preso più di me.” Quest’idea che non sia mai abbastanza in certe cose, che dobbiamo continuare a inseguire sempre di più — anche se in realtà questo non ci darà realizzazione né felicità, e non ci darà neppure successo a lungo termine. Quello che dobbiamo fare è spostare quella cintura motivazionale verso l’interno, pensando a come possiamo davvero fare al meglio il nostro lavoro — specialmente nel servizio pubblico, perché è un lavoro davvero appagante, motivante e gratificante.
È un po’ come guidare un’auto elettrica rispetto a un’auto a gasolio pesante — dovrebbe essere un’esperienza piacevole di per sé. E sappiamo che i pilastri chiave della motivazione intrinseca sono legati allo scopo — quel senso di come il lavoro aiuta e serve gli altri — e all’autonomia — quel senso di essere noi a controllare il nostro destino, come leader delle politiche pubbliche. Infine, c’è il diventare dei maestri — cioè diventare via via un leader sempre migliore. Non arriveremo mai alla perfezione, ma miglioriamo, ci sviluppiamo, cresciamo. Quindi scopo, autonomia e maestria sono fondamentali per spostare davvero il quadrante verso l’interno. E sappiamo che questo ha molte più probabilità di portarci a essere felici, realizzati e di successo.
MB: Una delle cose che fai molto bene nel libro è riportare molte ricerche accademiche che supportano la tua tesi sulla motivazione intrinseca. E penso che soprattutto la parola “scopo” sia diventata una di quelle parole d’ordine di cui tutti parlano — molti dirigenti aziendali, molte persone in politica dicono che dobbiamo avere uno scopo chiaro in tutto. Qual è l’evidenza che lo scopo conta e può davvero fare la differenza? E, con un pizzico di scetticismo, come distingui il vero scopo, quello legato al cambiamento reale, dal tipo di scopo da pubbliche relazioni di cui molti sono tentati di dire di essere dotati, se sono sotto pressione nei loro ruoli di leadership in questo momento, per cercare di suonare attraenti verso i millennial?
SJ: Penso che tu abbia centrato il punto giusto. Molti problemi con questa discussione sullo scopo derivano dal fatto che è stata portata in un territorio da pubbliche relazioni, e migliaia di dipendenti partecipano a workshop aziendali o governativi in cui vengono bombardati con slogan di scopo da parte dell’azienda e così via.
Quello che ho cercato di fare sul tema dello “scopo” è partire da una definizione molto semplice. Ho cercato di definirlo dai primi principi, concentrandomi su come quello che facciamo aiuta e serve gli altri — togliendo tutto il linguaggio pomposo. La sfida, secondo me, è che in realtà le organizzazioni stanno diventando sempre più brave, a essere del tutto onesti, a definire lo scopo organizzativo — perché esiste quell’azienda, come aiuta e serve gli altri. Non credo che abbiamo ancora risolto la domanda di come noi, come singoli leader nel servizio pubblico, contribuiamo a quello scopo. Quindi quello che succede di solito è che veniamo assunti in un lavoro — diciamo in un governo di qualche parte, nella burocrazia — e, sarò sincero, finisci per sembrare quasi un robot lì per realizzare lo scopo del dipartimento o della divisione di governo. La sfida, però, è che oggi, specialmente i lavoratori più giovani, noi stessi vogliamo sentire un senso di missione personale. Cioè qual è la nostra Stella Polare?
Ti faccio un esempio personale: io aiuto organizzazioni e leader a riaccendere la spinta interiore tramite scrittura, coaching e consulenza. Insomma, aiuto organizzazioni e leader a riaccendere la spinta interiore scrivendo, facendo da coach e dando consulenza — è una frase molto, molto semplice di 15 parole. Ma è una Stella Polare davvero utile che mi aiuta a ricordare perché faccio quello che faccio. E se lavorassi per un’organizzazione — ora lavoro in proprio, ma collaboro con un’azienda, come ho detto — la domanda che mi pongo è: in che modo sto contribuendo allo scopo di quell’organizzazione? E d’altra parte, come fa quell’organizzazione a contribuire al mio? Come mi aiuta a raggiungere il mio scopo personale? E quando penso che entrambe le cose siano in armonia, allora abbiamo un grande matrimonio tra dipendente e organizzazione. Penso che si instauri un ottimo accordo motivazionale. Ma la tentazione è che tendiamo a dimenticare l’individuo e che tutti noi abbiamo bisogno di questo tanto quanto le organizzazioni.
MB: E poi parli anche di “autonomia” e “maestria”. Qual è il nodo critico oggi riguardo all’autonomia, e cosa intendi esattamente con questo termine?
SJ: Se guardi la vita politica di oggi, direi che siamo in una situazione di autonomia molto complicata, in cui ci sono due estremi. Parlo nel libro di leadership politica, dove puoi avere l’estremo opposto. Per esempio, negli Stati Uniti forse in entrambe le Camere sembra quasi che i legislatori individuali agiscano come Clint Eastwood, o se vuoi come un Lone Ranger solitario. Ma l’altro estremo è quando sei parlamentare, per esempio nel Regno Unito, e ti dicono sempre cosa fare. E come si trovi il giusto equilibrio tra questi due estremi è molto importante. Se hai molta autonomia stai rappresentando una comunità genuina di elettori per il tuo mandato elettivo. Ma allo stesso tempo devi anche fare in modo di aderire alla direzione generale del partito per cui sei stato eletto. Come si fa a trovare quell’equilibrio? Questo è un aspetto chiave del libro. Quindi non può essere né un estremo né l’altro. Non può esserci né micromanagement totale, né un Far West totale. Trovare come si negozia tra queste cose è un’idea centrale del libro.
MB: Tu però osservi che in generale le persone non si sentono molto autonome al lavoro, in questo senso.
SJ: Esatto. Per esempio, parlavo degli insegnanti nel libro, e abbiamo numeri record di insegnanti che lasciano ogni mese. Negli Stati Uniti 30.000, 40.000, 50.000 insegnanti al mese abbandonano la professione. Nel Regno Unito il 40% degli insegnanti vorrebbe lasciare. Non è perché non amano più insegnare. È perché sentono di essere microgestiti. I loro presidi, i loro dirigenti scolastici, chiedono: “Cosa direbbe l’Ofsted (Office for standard in education)?”, anziché chiedersi “Qual è la cosa giusta da fare per la mia scuola, per la mia comunità?”. Così spesso si sentono come pedine su una scacchiera gigantesca, incapaci di esercitare il proprio giudizio e la propria discrezione professionale. Questo è un colpo davvero devastante per la motivazione.
MB: E questo è un problema che riscontri in tutto il governo in particolare?
SJ: Direi di sì. Ho passato molto tempo a parlare con parlamentari in molti paesi diversi, sia nel mondo emergente che in quello sviluppato. E quel senso di non poter controllare il proprio destino — ad esempio, molti di loro volevano essere nel solco del “prendersi cura di una sola nazione”, dove invece non stavano davvero sostenendo l’intero paese. Si sentono sempre di più legati alle loro fazioni, anche quelle in cui sono eletti.
MB: La terza nozione è la “maestria”. Quindi hai scopo, autonomia e maestria. La specializzazione è stato un grande tema — tanto che ora ci sono molti libri su quanto siano pericolosi i silos. Perché siamo diventati così specializzati che non sappiamo davvero come dialogare oltre i nostri silos e pensare in modo integrato quando prendiamo decisioni. Ma cosa intendi con maestria? Intendi qualcosa di molto diverso da quello.
SJ: Nel libro parlo della “regola delle 10.000 ore”, e di come molte discussioni sulla maestria abbiano riguardato l’abilità tecnica. E ci sono molti esempi che lo confermano nei campi tecnici, ma oggi molto del futuro dei lavori prospera grazie alle competenze umane. Per esempio, come funzionario pubblico devi sapere come sviluppare politiche e leggi. Ma devi anche sapere come influenzare i ministri, come lavorare con i colleghi, come interfacciarti con discipline diverse.
Prendi la risposta al COVID, per esempio: quelle abilità umane sono molto più difficili da sottoporre a una semplice regola delle 10.000 ore. Si tratta molto più degli aspetti umani più ampi del nostro lavoro. E quindi come codifichiamo queste competenze — quelle che chiamo i “fondamentali dell’ordine della maestria” — e cerchiamo di renderle qualcosa su cui le persone vogliano davvero lavorare attivamente per diventare sempre più brave? Spesso sono cose che in realtà non compaiono nelle job description formali dei funzionari pubblici, eppure sono la magia del lavoro di oggi. E come le rendiamo esplicite? Come le codifichiamo? E come troviamo un modo sistematico per migliorarle, e trovare anche persone che possano nutrire le tue competenze mentre progredisci nella carriera?
MB: Facci un esempio di un approccio diverso che hai visto applicato, uno che si è davvero allontanato da quel tipo di approccio delle 10.000 ore, verso qualcosa di più olistico.
SJ: Faccio qualche esempio dalla mia esperienza con STIR Education. Avevamo una direttrice amministrativo-contabile fantastica. Era davvero brava a fare in modo che avessimo conti gestionali solidi e affidabili ogni mese. La sfida è che, mentre diventavamo più grandi come organizzazione, il suo ruolo è diventato molto di più che fare la contabilità tecnica: era spostato verso l’influenzare il nostro staff, o gestire i nostri programmi per gli insegnanti — per far sì che spendessero meglio i soldi, per farli sentire più a loro agio con le competenze finanziarie, per far sì che fossero in grado di usare i dati contabili stessi per prendere decisioni intelligenti. Così abbiamo fatto molto per cercare di abbattere le barriere. Cose semplici, come cambiare il suo posto in ufficio. Spesso chi fa contabilità tende ad avere la propria stanzetta o un suo angolo, perché pensa che quello che fa sia confidenziale. Io le dissi: perché non vai a sederti in posti diversi dell’ufficio ogni giorno, ogni settimana, così che incontri colleghi diversi, parli con loro, vedi la loro realtà? Ha passato molti giorni sul campo, nelle scuole, vedendo il lavoro sul territorio, e osservando i processi che magari stavamo facendo che alla fine potevano ostacolare il progresso. Quindi si è trattato di cercare di abbattere i silos. E tornando alla dichiarazione personale di missione: se pensi che il mio ruolo a livello di scopo sia produrre conti gestionali entro i termini e accurati, quello è uno scopo. Se invece pensi che il mio ruolo sia aiutare l’organizzazione nel suo insieme a prendere decisioni migliori, quello è un altro scopo completamente diverso. Quindi come fai a cercare di smontare alcuni degli schemi tradizionali di pensiero per aprire i ruoli nel servizio pubblico e renderli appaganti e motivanti?
MB: Hai parlato di STIR Education: il libro si apre con questa storia ispiratrice su come sei rimasto sorpreso, in un certo senso, dall’appeal del messaggio. Puoi parlarcene un po’: cosa è successo e perché questo ti ha dato speranza? Hai visto altri esempi da allora?
SJ: Sì, sono finito in questa faccenda per caso. Sono un economista di formazione, in fin dei conti. Credevo molto nelle competenze “hard” della vita, come la finanza, l’economia, ecc. Penso che quello che sia successo è che, iniziando nelle baraccopoli di Delhi, stavamo cercando grandi idee didattiche da condividere nel mondo. Trovare idee nelle parti più povere del mondo non era motivo di grande orgoglio per gli insegnanti. Ma in un certo senso, per i miei insegnanti quelle idee contavano davvero. Sono diventati persone importanti a pieno titolo, hanno provato soddisfazione nell’incontrarsi e condividere idee.
Quel fermento di energia avvenne quasi per caso, anche se a quel tempo non sapevamo nemmeno cosa significassero quei termini; stava solo accadendo che stavamo “sbloccando” scopo, autonomia e maestria quasi come sottoprodotto di quello che facevamo. Ci siamo resi conto che avevamo confuso il bambino con l’acqua sporca. In realtà la magia è stata quell’innesco negli insegnanti, quella riaccensione della motivazione, e questo ha davvero cambiato la mia visione del mondo.
Ora lavoro per una serie di organizzazioni — come consulente per L’Oreal e per il governo del Kenya, ad esempio. Ma l’idea di base è che in realtà tutti entrano in un lavoro, specialmente nel servizio pubblico, con un alto grado di motivazione intrinseca, proprio come quei insegnanti; ma più lavoriamo a lungo, le culture intorno a noi tendono a farci perdere quella motivazione. E allora il trucco è come fare a mantenerci motivati a livello individuale, nonostante tutto. Ma se siamo leader nel servizio pubblico, come creiamo culture che si basano su quella motivazione intrinseca, e ci fanno sentire sempre più motivati invece di portarcela via nel tempo?
MB: Penso che l’esperienza degli insegnanti in molte parti del mondo sia simile. Ci sono persone che erano idealiste quando sono entrate nella professione; poi sono state spossate dall’incrocio con la burocrazia, specialmente come dici tu con tutti i fattori “alla Ofsted” di dover fare sempre più test e sentirsi solo pedine su una scacchiera.
Credo che una delle cose che ci motiva in Driving Change è che questo sembra essere anche un problema nel servizio pubblico: la gente vorrebbe essere idealista nel servire l’interesse pubblico e la propria comunità, ma il governo, in particolare, è così poco attraente proprio perché in tanti modi sembra che non offra un’esperienza intrinseca e soddisfacente. Se hai cercato di aiutare professionisti come insegnanti, agenti di polizia, e anche altri aspetti del governo, hai trovato modi per cambiare il sistema in modo che il loro idealismo non debba restare a casa quando entrano in servizio?
SJ: C’è un intero capitolo nel libro sul servizio pubblico e sulla vita politica centrata, perché i nostri leader sono così importanti — come stiamo vedendo in Ucraina ora, e come abbiamo visto durante la pandemia degli ultimi due anni. Ho letto anche di Tony Blair che commentava di non voler andare in politica oggi, dato il livello di scrutinio, il trolling sui social media, tutte queste pressioni folli. Che ti piaccia o no, penso che molte delle persone più brillanti nel mondo, come dicevi, non pensino prima al servizio come dovrebbero fare. E una delle cose che potremmo provare a fare è creare un ambiente più motivante per i futuri politici.
Sto facendo un po’ di lavoro con apolitical e l’UCL su questo, un progetto piccolo ma affascinante. E consideriamo la questione dello scopo, questa idea che come legislatori o come parlamentari il nostro lavoro è aiutare e servire gli altri. Molte persone con cui ho parlato in tante Camere dei Parlamenti nel mondo sentono che quell’idea di “una nazione sola” — cioè che sei lì per aiutare l’intero paese — è andata persa a causa del fazionismo. E una delle idee che esploro nel libro è come possiamo cercare di ricreare un senso di scopo nazionale genuino che attraversi davvero le divisioni e i partiti politici, e si concentri su ciò che ci unisce più di ciò che ci divide. Nel libro ho guardato anche a Kennedy e a certe sue cose di tanti anni fa, su come cercare di trovare quel terreno comune e resistere alla tentazione di esasperare le differenze, solo perché fa guadagnare voti.
Sempre sull’autonomia — parlavo con ministri in vari governi, incluso quello del Regno Unito, che mi hanno detto di aver saputo dei grandi annunci di politica nazionale dalle prime pagine dei giornali, spesso indirettamente, e che erano i secondi a saperlo. E questo è diventato ridicolo durante la pandemia, quando i cambiamenti dei lockdown venivano fatti trapelare alla stampa prima che i parlamentari avessero la possibilità di leggerli. Questo prendeva in giro il processo parlamentare e demotivava i ministri e gli altri membri del parlamento. A causa delle pressioni di accountability e del controllo, primi ministri e presidenti tendono a creare piccoli gabinetti ristretti, con cinque persone in una stanza che decidono praticamente tutto. Ma abbiamo circa 100 ministri in un paese come il Regno Unito, tutti persone molto preparate e capaci. Capire come possiamo sfruttare le loro competenze e inserirle in una narrazione più ampia, e in quel gruppo più esteso, è un altro aspetto importante dell’autonomia.
Per quanto riguarda la maestria — parlando con gente per esempio nella House of Lords del Regno Unito, gli capitava di entrare in aula e gli veniva mostrato solo dove erano i bagni e come arrivare all’accesso del dibattito, ma niente di più, onestamente. E non permetteremmo mai che medici, avvocati o commercialisti venissero formati in questo modo. L’Institute for Government nel Regno Unito fa un po’ di formazione per i ministri ed è davvero ottima, ma non è obbligatoria, è molto ad hoc. E questo è un vero lavoro. Intendo dire, è un ruolo molto, molto difficile e impegnativo. Dobbiamo sviluppare meccanismi più formali di sviluppo della maestria che consentano maggiore apprendimento tra pari, più discussione, più condivisione di esperienze, oltre a una formazione formale per aiutare i nostri leader eletti a formarsi meglio.
MB: Applicheresti lo stesso schema anche ai funzionari pubblici, e alle persone che intraprendono altre carriere nel servizio pubblico, non come eletti ma come una normale carriera?
SJ: Penso siano aspetti molto simili. Una delle cose interessanti sul tema dello “scopo” per i funzionari pubblici, di cui ho parlato con molti alti dirigenti del governo britannico, è per esempio che devi in qualche modo accettare che il partito al potere potrebbe non avere le tue stesse opinioni, ma il tuo lavoro è assicurarti che la direzione su cui sei stato eletto sia attuata nel modo migliore possibile. Questa è una domanda interessante di scopo, perché c’è una tensione tra quello che tu ritieni giusto personalmente e quello che il tuo ruolo richiede. Ma i funzionari con cui ho parlato mi dicono davvero: “Che io sia o meno d’accordo con questo, sono riuscito a fare in modo che i bisogni del mio paese venissero messi in azione.”
Per quanto riguarda l’autonomia, nel servizio pubblico c’è molta sorveglianza e di solito è molto facile perdere il lavoro se fai qualcosa di sbagliato. Quindi a volte c’è un po’ di cautela eccessiva. Quello che mi preoccupa è una cultura difensiva. I migliori funzionari pubblici che conosco sanno come esporsi. Ma sanno anche quando stare attenti. Semplicemente sapere quando abbassare la testa e farsi da parte è un elemento chiave.
C’è poi la maestria — oggi ci sono più meccanismi formali, sviluppo professionale, networking professionale, specialmente tra dipartimenti e tra livelli gerarchici. Ne vedo sempre di più, ed è un segno molto, molto incoraggiante. Perché, di nuovo, molte delle competenze chiave nel servizio pubblico oggi non sono formalmente descritte nel lavoro. Come le troviamo? Lo facciamo attraverso l’apprendimento tra pari, facendo esperienze e svolgendo le attività. Quasi nessuna politica si mette a riflettere dopo: “Ha funzionato? Cosa ha funzionato e cosa no?” Dobbiamo assicurarci di creare spazi riflessivi dove i funzionari pubblici possano esaminare quello che hanno fatto e usarlo come leva di miglioramento.
MB: Mi pare che nulla di tutto questo implichi pagare loro di più o altri miglioramenti salariali. Penso che si parlasse ovviamente di stipendio, bonus, status, ecc., come elementi di base fondamentali. Guardando il governo e il servizio pubblico, magari paragonandolo alla tendenza crescente di persone entusiaste del servizio pubblico che però vogliono andare a lavorare in aziende private o no-profit — dove di sicuro, dal punto di vista aziendale, avrebbero offerte migliori in termini di quegli elementi di base come stipendio e status — quanto incide il problema dello stipendio nel dissuadere molti idealisti dal prendere davvero la strada del governo? E pensi che dobbiamo risolvere quelle basi prima di poter affrontare gli aspetti intrinseci, come maestria, scopo e autonomia, di cui abbiamo parlato?
SJ: Penso che la ricerca sia abbastanza chiara: dipende da dove ci collochiamo rispetto ad altre professioni. Penso che la maggior parte delle persone nel servizio pubblico si aspetterà sempre una sorta di “sconto” rispetto al settore privato — nella pratica, è ciò che succede. Ma bisogna solo assicurarsi che sia gestibile. E che permetta di mantenere dignitosamente la propria famiglia, se ne hai una. Dunque non dobbiamo trascurare questo aspetto: dobbiamo continuamente assicurarci che le persone possano vivere una vita decente con qualunque sia il loro stipendio, sia che si tratti di cariche elettive, sia di funzionari pubblici.
Ma oltre a questo, penso che guardando l’esempio dell’India, dove lo stipendio degli insegnanti è aumentato progressivamente e gli insegnanti sono diventati alcuni dei più pagati al mondo in rapporto al PIL pro capite, non ha influito sulla loro motivazione. Quindi non possiamo trattare lo stipendio come una bacchetta magica. È bene assicurarci di impostarlo in modo sensato, ma quello che conta davvero sono i fattori intrinseci. La maggior parte delle persone entra nel servizio pubblico perché vuole fare la differenza nel mondo o nel proprio paese. Dobbiamo puntare su questo e costruire culture che li aiutino a farlo. E se lo facciamo, saranno motivati. E questo si tradurrà in una migliore retention dei funzionari pubblici, e porterà più persone a volersi unire a quella professione in primo luogo. Si creerà un circolo virtuoso, e probabilmente il pubblico sarà più incline ad accettare stipendi più alti per i funzionari pubblici, o per i parlamentari, col tempo. In un certo senso si crea un circolo virtuoso se si segue la giusta strada intrinseca.
MB: Riprendiamo il punto sugli insegnanti. Cosa hai visto di più efficace mentre lavoravi con insegnanti indiani — persone relativamente ben pagate, molte delle quali non si presentavano neanche regolarmente al lavoro? Come avete capovolto quella situazione?
SJ: Sì, abbiamo scoperto che era abbastanza semplice. Per noi, abbiamo cercato di capire come iniettare scopo, autonomia e maestria in un sistema scolastico. E abbiamo cominciato gestendo delle “reti di insegnanti” — gruppi di circa 20-25 insegnanti che si riunivano ogni mese e seguivano un processo strutturato per costruire la loro motivazione, dargli un senso di scopo, dargli un senso di autonomia. Provavano nuove tecniche, imparavano a fare cose da soli, vedevano cosa era possibile, e inoltre sviluppavano la “maestria”: imparavano a diventare sempre più bravi. E facevano tutto ciò in un’esperienza collettiva, divertente e coinvolgente.
Poi abbiamo capito che quelle reti dovevano moltiplicarsi. Sono passate da una singola rete a Delhi nel 2012 a circa 8.000 reti al mese adesso, coinvolgendo circa 200.000 insegnanti, in circa 35.000 scuole. Con questo progresso abbiamo realizzato che quello che contava di più erano i leader del sistema: cioè le persone che gestiscono gli insegnanti nei sistemi educativi. Dovevamo far sì che anche loro aderissero a questa idea, perché altrimenti avrebbe sempre avuto dei limiti. Così abbiamo iniziato a formare quei dirigenti a far funzionare le reti. E abbiamo lavorato con alti funzionari nei governi e nei ministeri per supervisionarle, per fare in modo che fossero parte del budget formativo. Insomma, si era creata una sorta di staffetta di modelli da imitare su tutti i livelli del sistema. E tutto questo non è costato molto. Credo che il costo per gli insegnanti fosse di circa 20 dollari USA all’anno, per lo più coperti dai budget di formazione esistenti. Non si trattava di soldi. Si trattava, come dicevi tu, di creare quello spazio e di avere la volontà di provare nuovi modi di fare le cose.
MB: E quali prove avete visto che funzionasse?
SJ: Abbiamo visto prove piuttosto convincenti che l’assenteismo si è ridotto significativamente. Inoltre, le relazioni tra insegnanti e studenti sono molto migliorate — gli insegnanti conoscono i nomi dei bambini, li coinvolgono di più, li considerano come individui e li educano in modo più efficace — sono aspetti che abbiamo tutti notato.
MB: Un’altra grande area del servizio pubblico che ha suscitato molte domande sulla motivazione e sulla cultura del momento è la polizia. Ne parli un po’ nel libro — cosa pensi debba succedere lì?
SJ: Abbiamo sentito parlare di William Bratton e di certe teorie negli Stati Uniti, poi Malcolm Gladwell ne ha parlato, e c’è del vero in quello. Credo che l’uso dei dati abbia migliorato le cose. Ma ha anche in qualche modo generato questa cultura, o questa idea sbagliata, che bisognasse trattare ogni singolo agente di polizia come una pedina su una scacchiera e spingerlo a fare operazioni statistiche. Questo ha minato pesantemente il senso di autonomia.
Credo che dobbiamo ripensare a questo e ricordarci che i poliziotti sono esseri umani, hanno affrontato tante sfide — con movimenti come Black Lives Matter e le fiaccolate dell’anno scorso nel Regno Unito — quindi come li aiutiamo a ritrovare quel senso di professionalità, a riportare un senso di dignità professionale e motivazione nel loro lavoro? Ricordiamo che il lavoro di polizia, soprattutto, ha molti aspetti che non possono essere ridotti a un foglio di calcolo — è altamente discrezionale, bisogna avere un gran fiuto e giudizio. È quello che chiamo una “professione complicata” — nel senso che non c’è nessuna soluzione tecnica facile. Dobbiamo aiutarli a creare le condizioni affinché possano prendere le decisioni giuste al momento giusto. E incoraggiarli a farlo, facendoli sentire supportati nel farlo. Quindi penso che dobbiamo ripensare l’approccio della polizia basata solo sui numeri.
MB: Avete, anche qui, sperimentazioni che hanno funzionato in questo senso?
SJ: Stiamo appena cominciando. Stiamo lavorando con un gruppo chiamato IDFC. Ho avuto modo di parlare con diversi alti ufficiali in India, per esempio, e veramente leader dinamici nel corpo di polizia. Prendiamo l’India come esempio. Ciò di cui hanno bisogno è la libertà di non dover combattere solo i fantasmi del cambiamento e della cultura, perché questa è sempre la parte più difficile. In particolare, come aiutare gli agenti di polizia e gli operatori in prima linea, che spesso si sentono piuttosto demotivati? Come aiutarli a costruire fiducia con i cittadini, in modo che i cittadini non li vedano solo con diffidenza? E che ci sia un senso genuino di collegamento con la propria comunità. Se si centra questo punto, possono accadere cose enormi. Ho visto alcuni piccoli esempi nel nostro primo lavoro di ricerca, dove questo era possibile. Ora la domanda è: come possiamo cercare di scalare tutto ciò e farlo diventare una norma più diffusa?
MB: Siamo quasi alla fine. Volevo concludere chiedendoti — qual è stato il cambiamento più grande nella tua vita, dopo esserti immerso in questo pensiero sulla motivazione intrinseca? Cosa consiglieresti a chiunque voglia davvero riconnettersi con questa spinta intrinseca, oltre a leggere il tuo libro?
SJ: Uno degli aspetti più interessanti per me, nello scrivere il libro, è stato guardare anche alla vita personale — la nostra vita, le nostre relazioni, e il ruolo di genitore. Io sono sia marito sia padre di due bambini piccoli. E mi ha davvero fatto rivedere alcune cose. Prendiamo ad esempio il ruolo di genitore. Che tipo di genitore voglio essere per i miei figli? Come li aiuto a essere motivati? Io, come tanti genitori della classe media, ero colpevole di spingerli da una attività all’altra: dal doposcuola, alla lezione di tennis, al corso di pianoforte, e così via. E in realtà mi sono reso conto di cosa conta per loro: amano la vita, amano imparare, e sono piccole brave persone. E hanno già un alto grado di motivazione intrinseca.
Così ho cambiato abbastanza radicalmente il mio stile di genitore da quando ho scritto il libro, cercando di essere più di sostegno, aiutandoli a trovare ciò che amano fare. Aiutandoli a sviluppare questo, aiutandoli a coltivare il loro scopo, la loro autonomia e la loro maestria. E mi è stato utile anche il fatto che se cerco di applicare alcune di queste cose alla mia vita, quell’effetto di modello da seguire — se loro mi vedono cercare di fare queste cose, può essere altrettanto potente. Quindi penso che il libro non parli solo delle nostre vite lavorative, che sono importanti, ma anche della nostra vita come esseri umani completi.
MB: Grazie mille. E qual è un consiglio pratico per chi volesse iniziare su questa strada dicendo: «Va bene, ho sentito quello che hai detto, leggerò il libro»? Ci sono passi pratici da fare subito?
SJ: La prima cosa da fare è scrivere ciò che chiamo il “costo dell’inerzia”. Quello che spesso succede è che non mettiamo per iscritto perché la realtà attuale, la mancanza di motivazione, ci fa tanto male. Ma ce ne dimentichiamo. Eppure lavoreremo circa 90.000 ore nella nostra vita lavorativa media. Se non siamo motivati, e andiamo avanti come se ogni giorno fosse una fatica insopportabile, questo ci costa emotivamente, socialmente e anche economicamente tantissimo. Basta scrivere come ci fa male. E questo può davvero ispirarci a dire: guarda, ne vale la pena, vale la pena provare, vale la pena correre un piccolo rischio — vale la pena fare quel primo piccolo passo di cui parlavo nel libro. Credo che a volte diamo troppo le cose per scontate. Metti nero su bianco il perché ti fa così tanto male. E questo ti darà la motivazione per andare avanti.
MB: Grazie mille, Sharath Jeevan. Il libro si chiama Intrinsic: Un manifesto per riaccendere la nostra spinta interiore. È un libro scritto benissimo, pieno di grandi intuizioni. Lo consiglio vivamente a tutti i nostri ascoltatori.
SJ: Grazie a te.