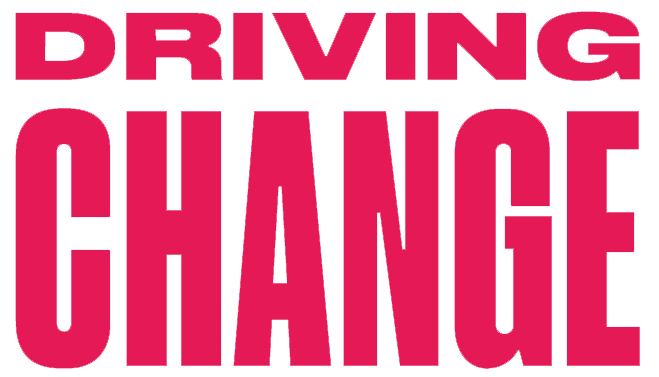È italiana l’internet delle merci, una rivoluzione dei trasporti pronta per essere realizzata. Si chiama Pipenet, è una rete di tubi sottovuoto nei quali viaggeranno capsule a levitazione magnetica a 1500 chilometri all’ora su tutto il territorio nazionale, e in prospettiva europeo. Merito di ingegno e buon senso: invece della sola levitazione magnetica dei treni di Shangai, ha anche il vuoto che permette di non avere l’attrito dell’aria, raggiungendo i 1500 km orari e oltre; invece delle mastodontiche dimensioni di Hyperloop, il progetto per il trasporto passeggeri la cui principale società è fallita a fine 2023, ha capsule di piccole dimensioni che portano due europallet ciascuna, 500 kg di merce, con una capacità di trasporto di almeno 3600 tonnellate all’ora. Driving Change ne ha parlato con il prof. Franco Cotana, che da 25 anni si batte per sviluppare e affermare il progetto, oggi Ad di RSE, Ricerca sul sistema energetico, società controllata dal Gestore dei Servizi Energetici per lo sviluppo di attività di ricerca nel settore elettro-energetico, con particolare riferimento ai progetti strategici nazionali.
Quando e come nasce il progetto?
Pipenet nasce 25 anni fa, da un lato dall’idea che i sistemi di trasporto stradale, soprattutto per le merci, stavano già subendo una saturazione, ma anche creando, per la promiscuità del trasporto stradale, problematiche relative alla sicurezza. Nonostante New Jersey, guardrail e altri sistemi che sono stati adottati, sappiamo tutti quanti siano gli incidenti anche purtroppo mortali, che coinvolgono quasi sempre o spessissimo mezzi che trasportano merci. Dall’altro, dall’affacciarsi della problematica dei cambiamenti climatici e della necessità di ideare un sistema che potesse ridurre il consumo dei combustibili fossili nel trasporto: quello dei trasporti stradali, ma direi in generale dei trasporti, è uno dei settori più difficili da decarbonizzare. Abbiamo così immaginato un sistema innovativo che, rispetto a quelli ferroviari, avesse anche il vantaggio di una capacità di trasporto elevata, ma di un impatto ambientale e anche di posa in opera più contenuto. Un po’ l’ispirazione viene dalle fibre ottiche che hanno soppiantato i fili di rame. Negli stessi cavidotti dove prima i fili di rame avevano un diametro enorme per trasportare le telefonate, con un sottilissimo filo di plexiglass, la fibra ottica, si è riusciti a trasportare molte più informazioni e diminuire le dimensioni. Qualcosa di analogo nasce nei trasporti: Pipenet aumenta la velocità del trasporto riducendo il peso trasportato per ogni istante, ma essendo la velocità elevata, la capacità di trasporto è importante: almeno una tonnellata al secondo. Ci sono 3600 secondi in un’ora….
Come lo avete coniugato?
Quest’idea poteva trovare una soluzione tecnica in un sistema che avesse alcuni elementi di fondo importanti. Primo, sappiamo che quando aumentiamo la velocità di qualunque mezzo nell’aria, nella superficie terrestre, andiamo incontro a una perdita enorme, che varia addirittura con il cubo della velocità, che è dovuta agli attriti delle ruote e all’attrito aerodinamico che impedisce di superare certe velocità, perché l’energia persa diventa talmente elevata che si perde qualunque vantaggio. Quindi bisognava eliminare l’attrito. Per farlo, per esempio, gli aerei adottano uno stratagemma: vanno ad alta quota dove l’aria è più rarefatta. Così il Concorde saliva a 30 chilometri di altezza per raggiungere una velocità superiore a quella del suono. L’unica cosa da fare era racchiudere questa specie di piccola ferrovia all’interno di un tubo e evacuare l’aria. Evacuare l’aria significava eliminare quel fattore di attrito aerodinamico che invece caratterizza anche i treni ad alta velocità, perché quando si superano i 60-70 km orari l’attrito aerodinamico è preponderante. D’altro canto, però, andando nel vuoto a velocità di 1.000-1.500 fino a 2.000 km orari, occorre cambiare tipo di contatto con la rotaia o con il supporto fisso, puntando su una levitazione magnetica che permetta di eliminare anche gli attriti di rotolamento verso la rotaia.
Quali erano le esperienze precedenti?
Alla fine degli anni ‘90 erano già stati sviluppati studi e ricerche sui treni a levitazione magnetica. È il caso di quello che nel 2005 è entrato in esercizio commerciale, e tuttora lo è, tra l’aeroporto di Shanghai e il quartiere di Pudong, lungo 30 km. Va a più di 450-500 km orari, purtroppo però con costi elevatissimi proprio per l’attrito aerodinamico; anche in Giappone sono state fatte sperimentazioni, ma se si vuole andare più veloci si deve eliminare l’aria. Da queste idee si incomincia a studiare la pratica all’Università di Perugia, poi l’ateneo umbro accoglie un centro che si chiama CIRIAF – Centro Interuniversitario per la Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici – che raccoglie una decina di atenei in Italia mettendo insieme le competenze scientifiche di vari settori, e si arriva a definire uno standard. Si fanno i brevetti nel 2005, e grazie a ciò si raggiunge un primo importante step quando il 26 gennaio del 2005 viene sottoscritto un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia, il cui Magnifico Rettore era il Professor Francesco Bistoni, e AnsaldoBreda Trasporti, con l’allora Presidente Ingegner Fausto Cutuli, presso la sede di Finmeccanica, oggi Leonardo. Accordo che dura 10 anni fino al 2015 e poi si poteva estendere. Ma purtroppo viene meno Ansaldo Breda Trasporti, Finmeccanica si trasforma e vende questo asset, che oggi si chiama Hitachi e si trova a Napoli. Quindi vengono meno alcuni supporti industriali che erano molto importanti. Cionondimeno la ricerca va avanti, si ricevono finanziamenti sia dal Ministero dell’Ambiente che in parte dall’Unione Europea e si realizza un prototipo a Terni di 100 metri di lunghezza con due piccole stazioni.

Un progetto resiliente, insomma. Negli ultimi anni come si è evoluto?
Si è continuato a fare studi e ricerche su varie tipologie di sospensione magnetica anche con superconduttori, utilizzando la sublimazione ed altre tecniche. Questi studi poi hanno condotto verso il 2020 alla definizione di uno standard che è l’oggetto di un progetto che è stato finanziato per via di un bando per le Regioni del Sud. Il progetto si chiama LOVE4PIPENET e vede come capofila l’Università Partenope di Napoli. Consiste nella realizzazione del laboratorio per i test dei componenti elettronici che sono stati brevettati, ideati in una concezione ancora più innovativa rispetto all’idea iniziale, fermo restando le tecnologie che abbiamo descritto: la tecnologia del vuoto, della levitazione magnetica, della propulsione elettrica (lineare e non) delle capsule. Il laboratorio, che sta per essere avviato in questi giorni, permetterà di testare sotto vuoto addirittura una camera climatica 10 alla meno 5, un vuoto molto spinto, e tutti i vari componenti che poi costituiranno gli elementi essenziali di questa infrastruttura. Contemporaneamente, il 17 dicembre del 2024 RSE, che nel frattempo è guidato dal sottoscritto che conosce bene questi progetti, ha siglato con RFI un accordo che permette di fare studi e progetti relativi a questa tecnologia. La previsione è che le dimensioni contenute – non parliamo di diametri enormi di 5-6 metri simili a tunnel proprio stradali, ma di un metro e mezzo, un metro e 60 al massimo – possano affiancare le infrastrutture ferroviarie italiane. Vogliamo quindi studiare tutte quelle interferenze con viadotti, gallerie e normali rilevati delle pertinenze ferroviarie che caratterizzano la rete nazionale. Quindi si ipotizza grazie a questo accordo – previa realizzazione dei componenti a Nola – di progettare un primo impianto presso il campo prove laboratorio di RFI che si trova a San Donato di Bologna, dove vengono testati anche i treni a idrogeno della Alstom, perché c’è sia lo spazio, sia i binari, sia un circuito di facility che ben si presta a queste nuove sperimentazioni.
Altri progetti troppo ambiziosi non sono andati a buon fine…
Nel corso di questi anni abbiamo visto nascere dopo la nostra brevettazione idee come Hyperloop, che in qualche maniera si ispirano un po’ sempre alla stessa tecnologia ma che sono stati destinati al fallimento perché hanno preteso di trasportare persone e soprattutto in questo caso con dimensioni elevatissime, con pesi di decine di tonnellate. Basta fare due conti: i raggi di curvatura devono essere quasi infiniti, cioè dobbiamo andare sempre dritti perché quando alle velocità di oltre mille chilometri orari si incomincia a curvare nascono delle spinte enormi. Noi invece abbiamo puntato su dimensioni più piccole ma più frequenti: 500 kg in tutto, 600 kg compreso il carico e tutta la zavorra e tutti i dispositivi per ogni capsula. Ma la cosa più importante che differenzia il nostro progetto da Hyperloop è che l’idea è quella di realizzare una vera e propria rete simile ad Internet per le merci leggere, cioè un Physical Internet di cui anche l’Europa auspica la realizzazione entro il 2050.
In che modo si può realizzare un Physical Internet?
Se prendiamo Hyperloop sappiamo bene che si va da un punto A a un punto B, da lì ci vogliono stazioni enormi per cambiare direzione. Niente di tutto questo nella nostra idea: abbiamo sempre due tubi che si affiancano per costituire un’unica struttura dove questi due tubi sono comunicanti tra loro. C’è un tubo fatto come un’ellisse che raccoglie almeno due piccoli binari, uno su cui viaggiano le capsule a 1500 km orari, e uno all’interno dello stesso tubo sottovuoto che fa l’up and down tra le stazioni e permette – grazie a un’idea innovativa brevettata che è il porta-capsule – di trasbordare una capsula da un porta capsule a un altro. La capsula è pressurizzata e contiene la merce, due euro pallet per un peso di 500 kg. Prevediamo che ogni circa 30 km ci sia una stazione, perché 10 km servono per accelerare le capsule alla velocità di sincronismo a 1500 km orari, accoppiarle con un porta-capsule vuoto che già sta viaggiando sulla rete a quella velocità; si agganciano i due porta capsule, e la capsula può passare dalla porta capsule che è stata appena accelerata a quello della linea ad alta velocità e proseguire fino alla prossima destinazione. Questa tecnica vale anche al contrario: se una capsula sta viaggiando ad alta velocità ma arrivata a Firenze da Roma o Milano si deve fermare o deve deviare verso Livorno o un’altra località, la capsula che sta viaggiando viene affiancata da un porta-capsule sul secondo tubo e si trasborda, per poi essere rallentata fino alla stazione successiva e poi espulsa o deviata su un’altra rete trasversale. In questa maniera si crea una vera e propria rete interconnessa, con una logistica che preserva anche il vuoto. Abbiamo ideato delle stazioni con delle camere di depressurizzazione e di vuoto che permettono di conservare il vuoto: una capsula che deve partire deve sottrarre l’aria da questa camera, e quest’aria che viene sottratta può andare a rifornire di aria la capsula che sta arrivando, e viceversa. Un sistema efficientato che riesce a spostare almeno una tonnellata al secondo, ma praticamente senza che prelevi energia dalla rete perché tutta quella di cui ha bisogno viene prodotta dalla stessa infrastruttura attraverso pannelli fotovoltaici, con batterie che sono disposte lungo tutto il percorso della dorsale tirrenica, per esempio da Reggio Calabria a Milano. L’idea è quella di avere almeno 25-30 stazioni e un tempo di percorrenza da Reggio Calabria a Milano di meno di un’ora.
Come si muovono le capsule porta merci?
Le capsule vengono allocate all’interno di porta-capsule. Abbiamo una specie di binari, che però non vengono a contatto con il porta-capsule, che ha una sospensione magnetica: non ha come nella ferrovia delle ruote che girano sopra il binario. Però il binario serve per guidare il porta-capsule. La capsula viene imbrigliata dentro questo porta-capsule che si collega con altri e permette il trasbordo delle capsule stesse. La capsula ha una lunghezza di circa 4 metri e un diametro di un metro e venti, un metro e trenta, perché tutto il tubo ha un diametro massimo di un metro e sessanta; i tubi sono sempre due, quindi possiamo immaginare un tubo un po’ ellittico. Questi porta capsule sono distanziati sulla stessa linea uno dietro l’altro di circa 500 metri e viaggiano tutte alla stessa velocità, questo impedisce loro di collidere. Con il motore elettrico lineare si crea una specie di onda Nord-Sud, dobbiamo immaginare quei porta-capsule immersi in quest’onda che trascina alla stessa velocità di sincronismo tutta una serie di porta-capsule lungo la linea. In futuro sarà anche una possibile il trasporto dei passeggeri, ma solo quando sarà dimostrato che tutto funziona, che non ci sono incidenti, perché i requisiti di sicurezza per i passeggeri sono enormemente più elevati di quelli della merce. Quindi per adesso puntiamo sul trasporto merci, poi in futuro non si sa mai, potremmo anche immaginare di mettere tre o due persone, se sono più comode, in queste piccole capsule che potrebbero comunque alloggiare anche dei passeggeri. Per il momento puntiamo sulle merci, sul just in time, sull’eliminare tutti i magazzini, soprattutto per le merci deperibili, quelle che devono avere la catena del freddo, perché la velocità di delivery è così elevata che molti passaggi vengono saltati con un’efficienza del sistema elevatissima, dal sistema della catena del freddo a quello dei magazzini.
Che impatto può avere questo tipo di trasporto?
Possiamo immaginare una fabbrica in cui i componenti vengono fatti in diversi luoghi e poi arrivano con il just in time in un punto dove vengono assemblati. Il 70% della merce può viaggiare in scatole di montaggio di queste dimensioni e con questi pesi, quindi noi toglieremo il 70% dei tir, forse anche l’80% dei tir dalle strade. Certo quando c’è un trasporto eccezionale, per carità, se è eccezionale è eccezionale, però potremmo eliminare l’inquinamento ambientale ma soprattutto potremmo fare una vera propria profonda decarbonizzazione nei trasporti che è uno dei settori, insieme a quello degli edifici, più difficili da affrontare, hard to abate come si dice.
A che velocità viaggeranno le merci?
Abbiamo per il momento ipotizzato 1500 km orari, anche se la velocità di collaudo sarà circa di 2000, però la velocità di esercizio noi la immaginiamo sui 1500. Anche i raggi di curvatura sono compatibili con quelli dell’alta velocità in affiancamento alla TAV. C’è un altro aspetto importante che abbiamo previsto: l’isolamento sismico dalle vibrazioni tra treni e questa nuova infrastruttura, che appoggerà su dei piloncini con isolatori sismici che impediscono di trasmettere vibrazioni tra l’uno e l’altro sistema.

Quella del trasbordo è un’idea vostra?
Sì, e abbiamo ottenuto un nuovo brevetto proprio su questa tecnica che permette la possibilità di realizzare una vera e propria rete. Ci teniamo molto al fatto che questo sistema sia una rete, pipenet significa rete di tubi e vuole essere come internet: una rete non per il trasporto delle informazioni ma in questo caso per il trasporto a pacchetto di materia di qualunque genere, purché non pericolosa – ma questo è un test che si farà all’ingresso prima della spedizione, è previsto anche questo. Pipenet è assolutamente un progetto italiano. Così come c’è la chiocciola per mandare le e-mail, abbiamo individuato il simbolo del paragrafo per significare il send-to (§) della merce: anche questo fa parte dell’idea italiana, così come i prototipi sono stati realizzati in Italia, ne abbiamo uno per le fiere che portiamo in giro. Si potrebbe dire che abbiamo preso ispirazione dalla posta pneumatica, però il concetto è completamente diverso: la propulsione non è più la pressione dell’aria, ricordiamo che la posta pneumatica aveva dei consumi energetici altissimi, qui invece è proprio il contrario, abbiamo un consumo bassissimo e la cosa più importante è che il 70 per cento dell’energia che serve ad accelerare le capsule viene recuperata anche in frenata, perché non dispendendosi non avendo attrito con l’aria riusciamo a recuperarla. Quindi abbiamo un’efficienza elevatissima, riusciamo a produrre forse più energia di quella che serve per movimentare una tonnellata al secondo.
Pipenet raggiungerà anche le isole?
Proprio così. Il diametro dei tubi non è casuale, è stato scelto il massimo che può essere messo in opera dalle più grandi navi appoggio che posano le tubazioni per il metano, hanno questa dimensione di 58-60 pollici, un metro e 60 massimo: sono tecnologie già pronte, non è che bisogna inventarsele. Addirittura stiamo pensando che se dei gasdotti fossero inutilizzati di rifunzionalizzarli attraverso dei piccoli robot per installare dei segmenti della struttura binario all’interno, però questo ancora è allo studio.
È un progetto italiano o europeo?
Dobbiamo immaginare una rete internet per le merci che sia di dimensione europea, che darebbe un impulso straordinario all’economia. Immaginiamo che cosa significherebbe avere il vantaggio competitivo di avere pezzi di ricambio, elementi di qualunque tipo in tempi così brevi. Le tariffe di trasporto sono allo studio e permettono di ottimizzare la capacità di trasporto: ci sono dei periodi, per esempio durante la notte, nei quali la linea è un po’ più scarsa, e se non c’è priorità di delivery – se si devono trasportare dei sacchetti di cemento non c’è la necessità che arrivino con il just in time, in pochi minuti – allora i prezzi si abbassano, con un impatto relativamente modesto sulla quantità di merce da trasportare. Se invece ho un maglioncino di cashmere da 2000 euro che deve essere provato istantaneamente, abbiamo previsto che nelle stazioni ci siano i droni con aerovie urbane organizzate con punti di sicurezza nell’attraversamento stradale, con una torre di controllo, con degli slot che vengono venduti. Una vera e propria infrastruttura di trasporto che collega questa logistica fino al balcone o alla finestra di casa. Posso provare il pullover, non mi piace, lo restituisco e il drone lo porta via, e magari tornando indietro porta via anche l’umido: anche questo fa parte di una filiera che vuole immaginare un futuro dove il trasporto delle merci è completamente automatizzato da e per le abitazioni. Per l’umido abbiamo già progettato delle torri energetiche dove viene convertito in biometano, che può essere utilizzato nel quartiere e digestato come concime per i parchi urbani. È un’idea di un futuro di una città domotica super organizzata ma soprattutto a bassissimo impatto ambientale e in termini di rischio per le persone che non troveranno tir nelle strade.