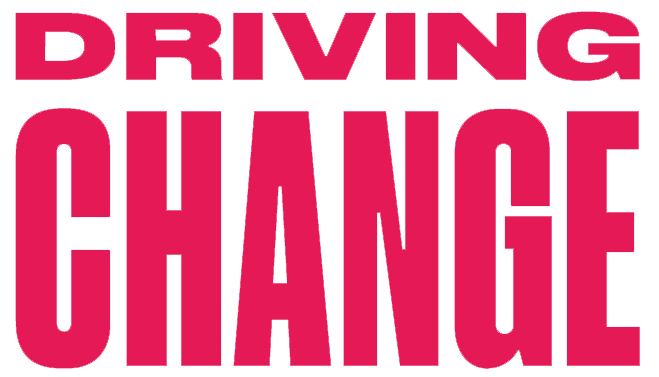Ron Gonen è fondatore di Closed Loop Partners e autore di The Waste-Free World: How the Circular Economy Will Take Less, Make More, and Save the Planet (Un mondo senza rifiuti: Come l’economia circolare consumerà meno, produrrà di più e salverà il pianeta). “Abbiamo un problema nell’economia americana — credo che esista in parte anche nel Regno Unito e in altri Paesi sviluppati — dove il massimo status sociale viene spesso attribuito a lavori che non generano necessariamente il maggiore beneficio sociale o che richiedono il maggior intelletto” dice Ron in questa intervista a Driving Change.
MB: Ron, ti chiedo di iniziare con una sola frase per spiegare al nostro pubblico — composto soprattutto da persone impegnate nel, o interessate al, servizio pubblico — perché dovrebbero leggere il tuo libro?
Ron Gonen (RG): Un mondo senza rifiuti offre ai lettori una visione di un sistema economico più redditizio, più equo e che preserva le risorse naturali.
MB: Il tuo libro inizia descrivendo una delle più grandi discariche del mondo, poi il primo capitolo apre con l’immagine delle mascherine monouso usate durante il COVID. Due immagini molto forti. Come siamo finiti in questo modello che chiami “economia lineare”?
RG: Ci sono due cause principali. La prima è la Rivoluzione Industriale, che ha introdotto la produzione di massa. La seconda arriva dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando quella macchina industriale, invece di ridimensionarsi, ha cercato nuovi modi per continuare a produrre. Così ha iniziato a fabbricare beni per la casa, in grandi quantità, sostenuta dall’industria pubblicitaria e da parte del governo USA. Questo ha trasformato il concetto di status: da qualità e risparmio a quantità e consumo. È lì che ha preso piede l’economia lineare.
MB: Mi piace l’espressione che usi, “economia del prendi-produci-getta”. E la tua spiegazione sull’obsolescenza programmata, come quella delle lampadine, è affascinante. Puoi raccontarci meglio quella storia?
RG: Quando la lampadina fu inventata, era possibile costruirne una che durasse quasi all’infinito. Ma le aziende hanno deciso di limitarne la durata, per poterne vendere di più. Così siamo cresciuti credendo che le lampadine si esaurissero per limiti tecnologici, quando in realtà era una scelta economica.
Un esempio attuale? Apple ha annunciato che venderà strumenti per riparare i propri prodotti a casa — un cambiamento radicale. Prima progettava dispositivi per diventare obsoleti in uno o due anni, ed era quasi impossibile ripararli da soli. Ora ha capito che trattenere il cliente a lungo termine è più sostenibile — anche per l’ambiente.
MB: Sarebbe bello anche poter usare lo stesso caricatore per più generazioni di iPhone…
RG: Esatto. Per anni nessuno si chiedeva come mai prodotti progettati da ingegneri brillanti durassero solo un anno. La verità è che quel modello economico — lo stesso delle lampadine — era basato sull’obsolescenza per stimolare le vendite. Ma ha generato montagne di rifiuti elettronici.
MB: Alcuni direbbero che criticare questo modello significa essere anti-capitalisti. Ma tu scrivi che in realtà è una forma di “socialismo per le imprese”. Spiegaci meglio.
RG: Un esempio è la plastica vergine rispetto a quella riciclata. Gli economisti dicevano che se la plastica riciclata fosse stata più economica, l’avremmo usata tutti. Ma la plastica vergine è artificialmente più economica grazie a miliardi in sussidi pubblici al settore petrolifero. Questo non è libero mercato, è un sistema truccato.
Lo stesso vale per l’energia: solo quando anche le rinnovabili hanno ricevuto sussidi, hanno potuto competere ad armi pari. Oggi, eolico e solare sono spesso più economici dei combustibili fossili.
MB: Lo stesso discorso vale per i rifiuti: il costo dello smaltimento non è incluso nel prezzo del prodotto. Spesso lo pagano i contribuenti, anche quelli che non hanno mai usato quel prodotto. E da qui nasce l’idea di economia circolare. Se l’economia lineare è “prendi-produci-getta”, cos’è l’economia circolare?
RG: È la capacità di produrre beni senza estrarre risorse naturali e senza mandare nulla in discarica. Questo abbassa i costi per le aziende, per i consumatori e per le amministrazioni. È un sistema più efficiente.
MB: Quando ha iniziato a diffondersi il concetto di economia circolare?
RG: In realtà è un concetto antico. Prima del 1940, per esempio, il latte arrivava in bottiglie di vetro riutilizzabili. Non si pagava per l’imballaggio. Dopo la guerra, invece, si è iniziato a pagare per imballaggi usa e getta, che costano di più e richiedono risorse. Quindi tornare all’economia circolare significa recuperare pratiche che funzionavano già — e bene.
MB: Ma ci sono ancora ostacoli da superare, tra cui la regolamentazione. Tu però vedi anche opportunità di investimento. Raccontaci di Closed Loop Partners.
RG: Closed Loop Partners è una società di investimenti e centro di innovazione focalizzata sull’economia circolare. Lavoriamo in quattro settori: beni di consumo e imballaggi, moda e abbigliamento, elettronica, cibo e agricoltura. Investiamo in tutte le fasi della crescita — venture capital, credito, equity, private equity.
Gestiamo anche un centro di innovazione per identificare soluzioni dove mancano e incubarle se necessario.
MB: E al momento vedete molte opportunità?
RG: Sì, moltissime. Lavoriamo con alcuni dei più grandi retailer, aziende tech, e gruppi di beni di consumo al mondo. Vogliono rendere più circolari le loro catene di fornitura. C’è molta innovazione, e ci sono ottime aziende che cercano capitali per scalare e soddisfare la domanda globale.
MB: L’incontro COP26 a Glasgow ha ricevuto molta attenzione mediatica, ma una volta concluso se n’è parlato poco. Il settore privato era molto presente e attivo, si è discusso molto di soluzioni e innovazioni da parte delle aziende. Tuttavia, l’evento aveva anche lo scopo di riunire i leader politici del mondo per elaborare regolamenti e trattati in grado di affrontare i problemi legati al cambiamento climatico e alla biodiversità. La mia impressione è che, nonostante tutte le dichiarazioni del settore privato, i leader politici non siano riusciti a coordinarsi davvero in modo da trasmettere fiducia sul fatto che riusciremo a evitare un peggioramento significativo della crisi climatica.
Qual è il tuo punto di vista? E come vedi l’equilibrio tra l’azione necessaria del settore pubblico e ciò che il privato può fare autonomamente?
RG: Come per tutti i movimenti sociali, la storia ci insegna che non esiste un unico evento che faccia scattare il cambiamento. Di solito una serie di eventi si rafforzano a vicenda fino a creare un punto di svolta. Credo che COP26 abbia avuto il merito di portare il problema in primo piano e generare entusiasmo per possibili soluzioni.
Tuttavia, ha anche avuto il difetto di offrire troppi spazi per impegni falsi. E per “falsi impegni” intendo tutto ciò che riguarda il 2050, perfino il 2040. Sono date troppo lontane. Nessuna azienda pubblica verrebbe presa sul serio se facesse previsioni su vendite o costi a 25 anni. Il CEO verrebbe deriso. Ma quando si tratta di clima, ci si prende applausi per lo stesso tipo di affermazioni.
A eventi come COP26 dovrebbe esserci una regola: va bene partecipare, serve un grande tendone che accolga tutti. Ma se entri nel tendone, parli di azioni a uno, tre, cinque, massimo dieci anni. Altrimenti è irrilevante.
MB: Quindi sostenere l’economia circolare non significa necessariamente credere a tutti questi impegni “net zero” dichiarati?
RG: Se qualcosa non è previsto entro il 2030, per me non conta. Il mondo cambierà molto da qui ad allora, e gli impegni presi oggi per il 2050 potrebbero non valere più niente. Dobbiamo concentrare le energie su cosa fare quest’anno, nei prossimi tre, cinque, sette o dieci anni.
Questo non vuol dire che risolveremo tutto entro il 2030, ma se ci impegniamo davvero, è entro quella data che possiamo affrontare la parte più grande del problema. Poi, nel 2029 o 2030, possiamo ridefinire i prossimi obiettivi.
MB: Come abbiamo già detto, le politiche pubbliche sono cruciali per permettere al settore privato di passare a un’economia circolare. Nel tuo libro ne parli in profondità, ma qual è secondo te la cosa più importante su cui i politici dovrebbero agire per accelerare questa transizione?
RG: Il costo dei rifiuti non può ricadere sulla collettività. Il modo in cui abbiamo strutturato il prezzo della gestione dei rifiuti è stato volutamente distorto da alcuni settori industriali che l’hanno modellato a loro vantaggio economico, non nell’interesse dei cittadini.
Pensiamo a come si paga l’acqua o l’elettricità: paghi solo quello che usi, a livello familiare. Nessuno accetterebbe di pagare per l’acqua o la luce del vicino. Ma i rifiuti sono una spesa comune: tu esponi la spazzatura, il comune la raccoglie e il costo si spalma su tutti i contribuenti. Questo sistema premia la pigrizia e lo spreco.
Dobbiamo trattare i rifiuti come un’utenza: ognuno paga per ciò che produce. A livello domestico e aziendale. E chi produce, paga. Questo stimolerebbe davvero la riduzione dei rifiuti.
MB: Qualcuno sta già facendo questo?
RG: Negli Stati Uniti ci sono comunità con sistemi “pay-as-you-throw”, dove paghi in base a quanto butti. In queste comunità il tasso di riciclo è molto più alto.
Alcuni stati, come il piccolo Maine e la grande California, stanno introducendo la responsabilità estesa del produttore: le aziende possono vendere ciò che vogliono, a qualunque prezzo, ma sono responsabili dello smaltimento del loro prodotto. Il contribuente non pagherà più. Se registri un profitto vendendo qualcosa, devi anche registrare il costo della sua eliminazione.
MB: Il tuo percorso personale è interessante: sei partito da un’azienda di riciclo, sei diventato commissario per il riciclo a New York nell’amministrazione Bloomberg e ora investi in aziende dell’economia circolare. Una delle nostre domande principali a Driving Change è: come facciamo ad attrarre persone di talento e consapevoli delle grandi sfide globali — come il cambiamento climatico — nel settore pubblico? E poi, come le tratteniamo? Oppure è meglio che seguano un percorso come il tuo, attraverso più settori?
RG: È una domanda importantissima. Penso che lavorare nel settore pubblico, anche solo per una parte della propria carriera, sia un’opportunità preziosa. E lo consiglio a chiunque ne abbia la possibilità, anche solo per un anno.
Come attrarre più persone? Non esiste una sola risposta. Una è avere un leader ispiratore, come Bloomberg o Obama, capace di trasmettere entusiasmo e attirare talento.
Un’altra è riconoscere maggiore status e valore sociale a quei ruoli. Negli USA (e anche nel Regno Unito) il massimo prestigio va spesso a lavori che non portano grandi benefici sociali o non richiedono grande intelletto.
I lavori di insegnante, pompiere, poliziotto, funzionario pubblico, soldato sono la spina dorsale della società. Eppure lo status e la retribuzione sono bassi. Questo crea un paradosso: le persone più brillanti vanno spesso in settori meno utili. Dobbiamo cambiare questa percezione.
MB: Mi ricordo che quando ho parlato con Bloomberg, da sindaco, diceva che su temi come la lotta al fumo era riuscito a fare molto più da politico che da filantropo. Non so se pensa lo stesso ora che lavora sul clima con la sua fondazione. Ma tu senti di avere più impatto oggi o quando lavoravi nel governo?
RG: Si può avere un grande impatto in entrambi i ruoli. Bisogna solo trovare dove si può fare più la differenza, secondo le proprie capacità e inclinazioni.
Alcuni possono dare il meglio nel servizio pubblico, altri nel settore finanziario, altri ancora come giornalisti.
Mike Bloomberg ha avuto una vita straordinaria, influenzando il mondo nel settore privato, pubblico e come filantropo. Ma non tutti possono (o devono) aspirare a quello. Ognuno deve trovare la propria vocazione e massimizzare l’impatto da lì.
MB: Ultima domanda. Nel tuo libro The Waste-Free World delinei un’agenda per un mondo a rifiuti zero. Guardando ai prossimi mesi, qual è la priorità assoluta per far avanzare questo movimento?
RG: La giustizia economica. Senza un senso di giustizia economica per la maggioranza delle persone, continueremo a ostacolare la transizione verso un’economia più pulita.
Ci sono miliardi di persone che vivono a malapena. Parlare loro di cambiare stile di vita senza migliorare prima la loro sicurezza economica è controproducente. Dobbiamo unire il discorso sul clima a quello sulla giustizia sociale.
MB: Hai aperto un tema enorme. Ma cosa considereresti un segno concreto di progresso in quella direzione?
RG: Basterebbe prendere tutti i soldi che il governo ha speso negli ultimi 50 anni per sovvenzionare l’industria del petrolio e del gas — e usarli per aiutare le persone povere ad accedere all’energia pulita.
Dobbiamo smettere con questa idea falsa che “il governo non può intervenire” o “non ha i soldi”. I soldi ci sono sempre stati — ma sono finiti a chi già era ricco. Se usassimo quei soldi, e solo quelli, per sovvenzionare le energie rinnovabili per chi ne ha bisogno, avremmo un mondo più equo, più sano socialmente e più pulito ambientalmente.
MB: Sembra un piano. Speriamo che succeda. E lavoriamo perché accada.
Ron Gonen, grazie per aver parlato con Driving Change del tuo libro The Waste-Free World. È un grande libro. Lo consiglio a tutti i nostri ascoltatori. Grazie ancora.
RG: Grazie a te, Matthew. È stato un piacere.