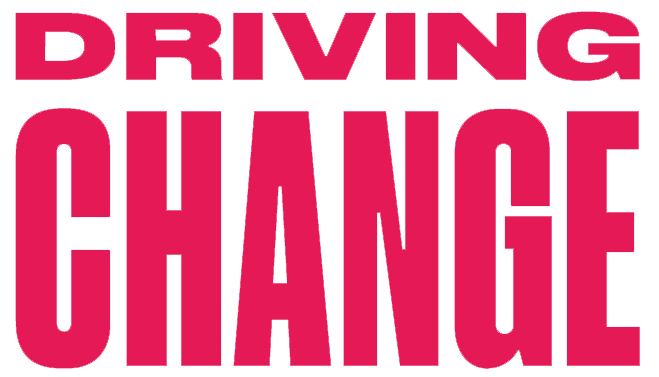Ascolta qui
François Bonnici è co-autore insieme a Cynthia Rayner di The Systems Work of Social Change: How to Harness Connection, Context, and Power to Cultivate Deep and Enduring Change (Il lavoro sistemico del cambiamento sociale: Come sfruttare la connessione, il contesto e il potere per coltivare un cambiamento profondo e duraturo). Un libro ricco di ottimi insight pratici e saggezza, di alcuni casi studio notevoli, poco familiari a molti, e anche di riflessioni molto importanti sul modo in cui il cambiamento avviene a livello globale e su come possa essere generato il cambiamento dei sistemi in futuro.
MB: François, vorrei cominciare come faccio con tutti i nostri ospiti: in una frase – considerando il nostro pubblico, che include persone impegnate nel cambiamento sociale o che stanno valutando di farlo – perché dovrebbero leggere il tuo libro?
François Bonnici (FB): Grazie, Matthew, per avermi invitato. Sono felice di essere sul tuo podcast e saluto tutti gli ascoltatori. Forse per la stessa ragione per cui vorrei leggere il libro io stesso. Inizialmente, io e Cynthia lo abbiamo scritto pensando: “sarebbe sufficiente se imparassimo qualcosa noi due”. Da accademici, ma anche lavorando nel campo delle fondazioni, ci sentivamo un po’ paralizzati dalle sfide travolgenti che affrontiamo, dalla loro complessità e dalle narrazioni sul cambiamento sistemico. Non avevamo la sensazione di poter portare un approccio concreto nella pratica quotidiana. Il libro si chiama systems work (“lavoro sui sistemi”) proprio per dare rilievo al lavoro quotidiano che dobbiamo fare e per enfatizzare che, per raggiungere un futuro cambiamento di sistema – qualunque esso sia – serve un processo di cambiamento, e persone coinvolte in quel processo. Speriamo davvero che sia un approccio pratico, radicato in duecento anni di cambiamento sociale, con casi studio approfonditi, centinaia di interviste a esperti, e che lasci al lettore storie emozionanti, ispiratrici, insieme a strumenti pratici e lezioni alla fine di ogni capitolo. Speriamo che contribuisca al percorso collettivo che molti di noi stanno seguendo per capire cosa intendiamo e come realizziamo questo lavoro verso un cambiamento sistemico più profondo e duraturo.
MB: Come siete arrivati tu e Cynthia a scrivere questo libro? Nasce dal lavoro fatto insieme al Bertha Centre in Sudafrica, giusto? Posso dire prima di proseguire che attualmente sei a capo della Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, creata dal fondatore del World Economic Forum e da sua moglie. Questo è di per sé un interessante punto di discussione sul ruolo dei sistemi – e sulla domanda se organizzazioni top-down possano davvero guidare un cambiamento dei sistemi. Ma come è nato il libro?
FB: È stata un percorso lungo: cinque anni. È iniziato prima del COVID e poi è stato rivisto e aggiornato durante il COVID, per motivi che spiegherò. Avevo fondato il Bertha Centre all’Università di Cape Town, primo centro per l’innovazione sociale in Africa, dedicato a capire approcci innovativi al cambiamento sociale, all’impresa sociale, a quello che facevano i movimenti sociali. Molto rapidamente abbiamo riconosciuto che gli approcci superficiali, o persino quelli orientati solo alla consegna di servizi, non affrontavano le sfide profonde e le barriere strutturali e sistemiche che caratterizzano il mio paese, il Sudafrica, a causa di centinaia di anni di storia. Nessuna soluzione fantastica avrebbe potuto annullare tutto questo.
È stata una barriera notevole e una fonte di fallimento, sia per me che per i progetti in cui io e Cynthia abbiamo lavorato, e per le organizzazioni con cui abbiamo collaborato. Molte di queste erano profondamente frustrate. Ma abbiamo anche visto organizzazioni incredibili superare ogni giorno quelle barriere sistemiche e strutturali legate allo stigma, alle trappole di povertà e alla mancanza di opportunità, trasformandole in agency, ovvero capacità di agire autonomamente.
In quel periodo abbiamo iniziato a esplorare, a fare ricerche e a collaborare con reti globali come la Rockefeller Social Innovation Fellowship. Abbiamo fatto anche un lavoro commissionato dalla Schwab Foundation, quando eravamo al Bertha Centre, chiamato Beyond Organizational Scale, per studiare come la pressione sociale genera cambiamento sistemico. Quello che abbiamo scoperto è che il discorso globale sul cambiamento dei sistemi era molto diverso rispetto a quello che vedevamo insieme alle organizzazioni con cui lavoravamo — prima in Sudafrica, e poi anche in America Latina, in India e negli USA.
MB: Mentre leggevo, una cosa che mi ha colpito è stata la chiara differenza di opinioni su cosa sia il cambiamento dei sistemi e come realizzarlo. Molti pensano a “aggiustare” un sistema dall’alto, ma voi avete trovato un’esperienza fondamentale diversa tra le realtà dell’attivismo di base.
FB: Penso sia corretto. E credo che siamo stati molto frustrati anche dalla stessa parola “sistemi”, perché ognuno la intende a modo suo. Se chiedi a qualcuno al WEF otterrai risposte diverse rispetto a chi fa attivismo alla base. Così sono diventato un po’ allergico al termine, e alla fine ho scritto un libro sull’argomento. Non per sminuire nessuno, ma nel libro spieghiamo che queste sfide hanno tre dimensioni: complessità, scala e profondità. Quello che abbiamo visto è che le discussioni si concentrano soprattutto sulla scala — se riusciamo a risolvere problemi o se tutti lo fanno nello stesso modo, questo sarebbe cambiamento sistemico. E se lo facciamo attraverso la lente della complessità, dove individuiamo leve, interveniamo in un sistema e alteriamo l’equilibrio tra attori, sistemi e relazioni, anche questo è una forma di cambiamento sistemico. Quello che però manca spesso è parlare dei passaggi. E temiamo che le dimensioni della scala e della complessità da sole possano perpetuare lo stesso sistema di attori al potere — se chi progetta il sistema o ha già il controllo è anche chi lo modifica. Questo libro, dunque, vuole porre l’accento sulla componente di profondità. Non solo un’aggiunta, ma il passaggio cruciale per combinare le tre lenti e unire strategie dal basso con quelle dall’alto.
MB: E perché siamo arrivati a questa situazione in cui anche durante eventi come il COVID, il WEF e il “Great Reset” il cambiamento appare ancora fortemente top-down? Si parla di Biden che spenderà 3,5 trilioni per infrastrutture, grandi numeri, cambiamenti industriali… ma le persone che dovrebbero beneficiare? Spesso sono coinvolte per ultime o senza potere decisionale. Come ci siamo arrivati?
FB: Nel primo capitolo del libro parliamo proprio dell’“industria del cambiamento sociale”. Ci sono radici storiche profonde: l’era industriale, il dopoguerra, la Green Revolution: momenti che hanno rafforzato certi approcci, mentalità e pratiche. E anche i flussi di finanziamento li hanno supportati. Un punto importante è il potere concentrato nel settore pubblico e privato, dissipato e frammentato nel “settore plurale” (preferisco questo termine a “terzo settore” o “non profit”), per la sua natura frammentata. Non ha potere decisionale collettivo, né autorità per definire strategie di cambiamento.
Questi attori sono stati, per tanto tempo, semplicemente destinatari di decisioni, sistemi e finanziamenti, e sono diventati molto dipendenti da quel sistema. Non è una narrazione nuova, ma offre una nuova prospettiva. In questo momento stiamo capendo che, se continuiamo così, non cambieremo davvero le regole del gioco. Ma noi che lavoriamo nel sociale siamo complici, in un certo senso: molte delle nostre carriere e mezzi di sostentamento dipendono dal fatto che i problemi persistano.
Per me la grande svolta è stata quando ho compreso che lo scopo delle organizzazioni non profit, delle imprese sociali, deve riportarsi dalla semplice erogazione di beni e servizi verso le persone alla capacità di generare agency e dare potere a chi vive quei problemi. Il libro sottolinea questa urgenza, e il valore intrinseco delle organizzazioni locali — piccole o grandi reti — nel costruire capitale sociale e coesione. Anche durante il COVID, la fiducia, il capitale sociale e l’essere presenti gli uni per gli altri ha avuto un impatto cruciale. Il testo si focalizza sul valore relazionale e su come lo costruiamo, perché è fondamentale per quei risultati aspirazionali a lungo termine che desideriamo.
MB: Hai menzionato questi tre elementi, che sono temi principali del libro: la Connessione, il Contesto e il Potere. La Connessione – i diversi modi in cui si può aiutare le persone a connettersi – è in una certa misura evidente, e tu citi alcuni ottimi esempi di chi lo sta facendo. Il Potere – il tuo messaggio è, in sostanza: dare potere alle persone, agli attori primari sul campo, a coloro che dovrebbero essere davvero aiutati; e il modo migliore per aiutarli è dare loro il potere di trovare le proprie soluzioni. Ma, parlaci un po’ di più di cosa intendi per Contesto e perché è così importante in questo momento.
FB: Allora, solo per dire qualcosa rapidamente anche sugli altri due, perché penso che siano tutti interdipendenti. Quindi magari andare un po’ più in profondità, così che chi ascolta possa dire: “ok, non è la solita discussione su connessioni e reti”. In realtà, è importante vedere anche le pratiche e le tattiche che queste organizzazioni usano per costruire identità collettive. E questo si collega anche al potere del contesto. Voglio sottolineare che sotto la superficie di questi tre grandi principi c’è molto di più, e li abbiamo riscontrati in tutte le organizzazioni che abbiamo studiato e nel loro modo di lavorare.
Abbiamo anche esaminato il concetto di pratiche. Sotto ciascun principio c’è un insieme di pratiche. A noi interessava particolarmente come tutto questo accade. Si può parlare di contesto, ma cosa succede davvero? Come lo fanno le organizzazioni? E noi abbiamo chiamato quel principio: abbracciare il contesto. In quel campo, ci interessava molto vedere quanto fosse cruciale oggi. E osservare anche grandi organizzazioni in grado di distribuire informazioni – quindi dati, la capacità di prendere decisioni – ai loro operatori in prima linea, alle comunità, ai cittadini che cercano di responsabilizzare. Il contesto è importante perché è lì che si prendono le decisioni.
Parte del nostro lavoro ha preso spunto dalla letteratura sulla complessità, dove si dice che il punto massimo di complessità si trova nel contesto. Se parliamo di scuole, ad esempio, è tra insegnante e alunno, o insegnante e famiglia. In ospedale, tra operatore sanitario e paziente. Il punto di maggiore complessità – paradossalmente – non sembra così complesso per chi lo vive, perché è proprio lì che si sa meglio cosa fare. Abbiamo visto molte volte organizzazioni che cercavano di implementare programmi in contesti diversi. Il solito schema: “ha funzionato qui, replichiamolo altrove.” Ma per una serie di ragioni questo non funziona. È tutta una questione di contesto. Il problema è che chi implementa un programma – un dipendente, un responsabile di progetto, un portfolio manager – si ritrova a fare un lavoro altamente relazionale, per far funzionare la procedura standard. E se non si riconosce quel lavoro, se non si danno risorse e potere decisionale agli operatori sul campo per fare quel lavoro contestuale, per costruire relazioni, allora il fallimento è quasi assicurato. Ma quando queste organizzazioni riescono, è proprio perché fanno questo lavoro relazionale – come mothers2mothers, Our Labs, e altre organizzazioni che abbiamo studiato. E attenzione: questo non significa che tutto debba essere piccolo e locale.
Un esempio molto interessante nel libro è Buurtzorg, con sede nei Paesi Bassi. È presente in 20 Paesi, con un fatturato di 40 milioni di euro. Non è una ONG microscopica. Eppure, fino a poco fa, non avevano né un responsabile HR né un CFO. Avevano una tecnologia molto forte che permetteva alle infermiere, che lavorano nei quartieri con gli anziani, di avere tutte le informazioni, di prendere decisioni sulle risorse, sui budget, persino sulle risorse umane dei loro piccoli team locali. Durante il COVID, abbiamo visto quanto invece fosse difficile per le case di riposo reagire con agilità, dovendo aspettare decisioni top-down, rispettare protocolli. Io stesso ho lavorato da medico, e una volta che sei dentro quel sistema, devi seguire il sistema. Quindi vedere come Buurtzorg abbia equipaggiato e responsabilizzato le persone sul campo ha prodotto una maggiore partecipazione e risultati molto più interessanti.
Un altro esempio che ho già citato è la Family Independence Initiative (ora UpTogether), fondata da Mauricio Miller. Aiutavano famiglie povere negli Stati Uniti, per lo più di minoranze. E una volta, lui licenziò un dipendente per aver “aiutato” una famiglia. Perché il lavoro non era aiutare, ma fornire dati, informazioni, elenchi di opportunità, un gruppo tra pari e un’infrastruttura IT, in modo che le famiglie potessero decidere da sole cosa fare del proprio futuro. Un cambiamento di prospettiva radicale. Non risolvere problemi per gli altri, ma dare alle persone la possibilità concreta di farlo da sé.
MB: Hai menzionato il COVID. Ti ha reso più ottimista o più pessimista sul fatto che queste lezioni possano essere apprese e applicate? Perché questa è la terza o quarta crisi in 20 anni. Ogni volta diciamo: “non sprechiamo una buona crisi”, “dobbiamo ricostruire meglio”, eccetera. Tu, da dove sei seduto, vedi che stiamo imparando?
FB: Comincio dalle organizzazioni che abbiamo studiato. Siamo tornati da loro con l’ipotesi che: il lavoro fatto per costruire fiducia, valore relazionale e distribuzione dell’agency le avrebbe rese più reattive e rilevanti durante il COVID. E sì, crediamo che sia stato proprio così. Queste organizzazioni hanno fatto un lavoro incredibile in questo periodo. Ma… questo è stato capito dagli altri? Abbiamo davvero imparato qualcosa da questa crisi? Credo che una cosa che abbiamo capito – almeno nel contesto sudafricano, dove se ne parla apertamente – riguarda i pregiudizi razziali, le barriere di classe, il genere. Tutte dinamiche rese molto più evidenti a livello globale.
Questo non è solo un problema del Sudafrica. È globale. E in un certo senso, la consapevolezza che i problemi hanno radici strutturali e sistemiche è cresciuta. Ma non siamo riusciti a superarle con gli approcci tradizionali. Dall’altra parte, il mio ruolo è a volte paradossale: rappresento una fondazione che si occupa di persone vulnerabili ed escluse, ma anche in interfaccia con il WEF, che rappresenta la leadership attuale. E, nonostante la narrativa, per i leader di oggi è difficile davvero fare i cambiamenti radicali di cui abbiamo bisogno, quando il loro mandato è stabilizzare e mantenere lo status quo. Ci sono sprazzi di speranza, ma non abbastanza rapidi o radicali. Quindi sì, ho un cauto ottimismo, ma vedo anche che non stiamo sfruttando davvero la crisi come occasione. Forse è il fatto che ci troviamo davanti a crisi multiple, o forse che non riusciamo a trasformare le lezioni del COVID in cambiamenti di lungo termine. E questo mi preoccupa molto.
MB: Ultima domanda. Il libro si rivolge in particolare a chi guida organizzazioni per il cambiamento sociale, soprattutto non profit. Ma il contesto è che i governi hanno gran parte delle risorse. Il settore filantropico finanzia molte iniziative. E le imprese stanno iniziando (forse) ad abbracciare un approccio più orientato agli stakeholder. Qual è il messaggio del libro per questi gruppi? E per chi ci ascolta e si chiede “Come posso contribuire?”, quale consiglio daresti?
FB: Innanzitutto, il libro è per tutti nel settore sociale, non solo per i leader. Interessante: ho ricevuto una telefonata dal Brasile dove vogliono tradurre il libro in portoghese, perché tanti operatori sociali sentono che questo libro riconosce il valore di un lavoro che spesso non viene riconosciuto. Certo, è per chi guida il cambiamento sociale, e per chi lavora in queste organizzazioni e si pone domande. Speriamo che fornisca spunti pratici, ma anche strumenti per riflettere dentro l’organizzazione, e per avviare dialoghi con i finanziatori. Siamo stati invitati a partecipare a gruppi di lavoro tra donatori e filantropi per discutere il contenuto. Perché c’è una riflessione interna che la filantropia deve fare su come sta evolvendo. E crediamo molto nell’approccio partecipativo, ma anche nella necessità di valutare aspetti diversi, e forse essere meno ossessionati da cose come il value for money, il social return on investment, i numeri. Non che non siano importanti. Ma in nome di quelle metriche abbiamo perso qualcosa di più profondo, che porta al vero cambiamento.
E poi, per i governi e le imprese: molte pratiche che raccontiamo si adattano al momento storico in cui i giovani, grazie alla tecnologia, hanno agency distribuita. Abbiamo strumenti come la blockchain, e dobbiamo capire come usare questi strumenti in modo utile. Credo che queste pratiche possano avere un grande valore anche nel mondo aziendale moderno, con una nuova generazione. E per i governi, in un momento in cui la fiducia nel pubblico è ai minimi storici, c’è bisogno di riabbracciare il settore sociale come parte integrante del futuro, e non solo come un “tappabuchi” per quello che lo Stato non riesce a fare. Quindi sì, ci sono diversi pubblici per questo libro. L’abbiamo voluto scrivere con un’ampia visione, ma anche andando a fondo su come si fa, concretamente, questo lavoro.